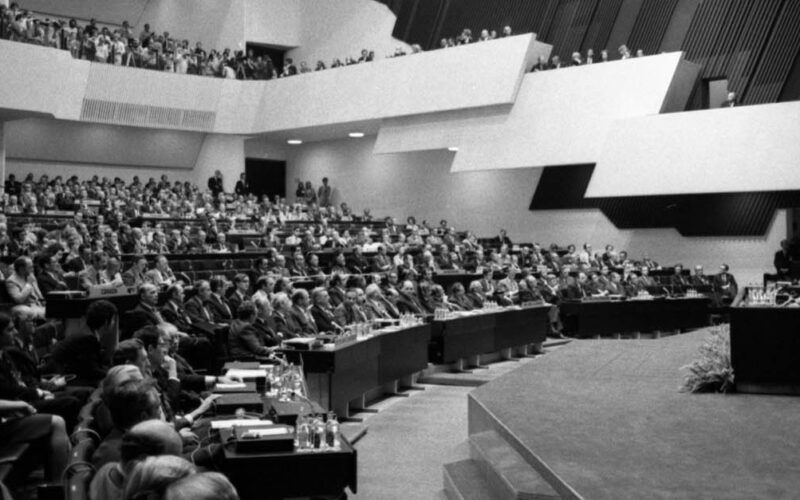14 Ottobre 2025
Péter Pál Orosz: il beato che non si inginocchiò davanti al regime
La storia di Péter Pál Orosz attraversa la Transcarpazia del ‘900. Nato sotto l’impero austro-ungarico, ordinato sacerdote nell’Ungheria alleata dei nazisti, consacrato vescovo in segreto mentre avanzava l’Armata Rossa, fu ucciso nel 1953 in Ucraina mentre pregava davanti a un crocifisso. La sua beatificazione arriva settant’anni dopo, nel mezzo di un’altra tragedia.
La Transcarpazia è uno di quei luoghi dove la storia del Novecento si è divertita a ridisegnare frequentemente confini e identità. Parliamo di quella regione ai piedi dei Carpazi che oggi appartiene all’Ucraina, ma che nel corso del secolo ha cambiato bandiera così spesso che i suoi abitanti più anziani si sono ritrovati cittadini di almeno quattro o cinque paesi diversi senza mai spostarsi da casa.
La popolazione era un mosaico: ruteni (o rusini), ungheresi, ebrei, tedeschi, rom… Economicamente era una delle zone più arretrate dell’impero, montagnosa, rurale, con una popolazione contadina largamente analfabeta. Anche dal punto di vista religioso il panorama era variegato: i ruteni erano in maggioranza greco-cattolici, c’erano poi minoranze ortodosse, gli ungheresi erano cattolici, gli ebrei costituivano una presenza significativa soprattutto nei centri urbani, e infine c’erano calvinisti e luterani.
Quando il 14 luglio 1917 a János Orosz, parroco greco-cattolico del borgo di Biri, e a sua moglie Erzsébet nacque il secondogenito Péter Pál, la Transcarpazia faceva ancora parte dell’impero austro-ungarico.
Biri era un insediamento molto antico, ma dal ‘500 aveva conosciuto il declino a causa di siccità, epidemie, incursioni turche e conflitti che l’avevano ridotto a località «desolata», come si legge in un documento del 1720. La rinascita avvenne solo alla metà del ‘700 grazie al conte János Péter Kállay che decise di ripopolare Biri trasferendovi abitanti da fuori. Dal punto di vista ecclesiastico, la parrocchia greco-cattolica seguì le trasformazioni istituzionali della Chiesa orientale in Ungheria: inizialmente dipendente dalla diocesi di Munkács (Muchačevo), passò definitivamente alla diocesi (oggi arcidiocesi) di Hajdúdorog, eretta da Pio X nel 1912.

Veduta del complesso greco-cattolico di Máriapócs, a pochi km da Biri. Retto dai padri basiliani, è il santuario ungherese più importante e visitato dai fedeli. (Globetrotter19, wikipedia)
Il 1918, oltre alla caduta dell’impero, rappresentò un punto di svolta per la famiglia Orosz: padre János morì a soli 31 anni durante l’epidemia di influenza spagnola, ed Erzsébet, poco più che ventenne, rimase da sola con i figli János István di quattro anni, e Péter Pál. Decise perciò di vendere le proprietà e nel marzo 1919 tornò dai genitori a Berezinka (oggi Ucraina). Oltre alla tragedia familiare, infatti, era in corso la guerra ungherese-rumena con la rapida e profonda avanzata dell’esercito rumeno in territorio magiaro: in Ungheria il crollo dell’impero aveva portato all’instabilità politica e al vuoto di potere fino al colpo di Stato di Béla Kun, il quale nel ‘19 aveva proclamato la Repubblica sovietica, comunista e nazionalista, che si era scontrata con le mire espansionistiche della Romania decisa a riunificare tutti i romeni, compresi quelli che vivevano nelle regioni della Transilvania, i quali fino a pochi mesi prima erano sudditi dell’Austria-Ungheria. La giovane Erzsébet, quindi, non voleva rischiare di trovarsi lungo la linea del fronte, separata dai suoi parenti.
Nel 1921 la vedova sposò il notaio Tibor Dudinsky (1896-1943), e la coppia si trasferì a Kerecki. Il matrimonio, però, durò poco: Erzsébet morì nel ’26. A quel punto, i suoi due figli János e Péter Pál si trovarono in una situazione delicata, perché Dudinsky nel frattempo si era risposato, e la sua nuova famiglia non volle accogliere i bambini che alla fine furono affidati alle cure della nonna.
Nel frattempo, con il trattato del Trianon del 1920, le regioni della Transcarpazia passarono alla Cecoslovacchia – scelta curiosa, visto che non c’erano né cechi né slovacchi in quelle zone, ma Praga voleva un confine comune con la Romania. Il periodo cecoslovacco, durato fino al ‘38, portò in Transcarpazia la modernizzazione e l’industrializzazione. Dal punto di vista etnico, gli ungheresi, che a lungo erano stati la classe dominante, ora erano una minoranza, mentre la Chiesa greco-cattolica mantenne la sua posizione centrale.
All’inizio degli anni ‘30 Péter Pál fu affidato alla famiglia di padre András Szabó, parroco di Sokyrnycja, e frequentò il ginnasio di Chust, per poi entrare (settembre 1937) nel seminario greco-cattolico di Užhorod. Intanto la situazione geopolitica stava di nuovo cambiando: nel 1938 la Cecoslovacchia finì smembrata dai patti di Monaco, e nel giro di un paio di anni l’Ungheria si riprese gran parte della Transcarpazia. Il periodo ungherese durato fino al 1944 rappresentò per gli ungheresi il «ritorno» alla madrepatria, per le altre etnie significò invece magiarizzazione forzata, cui si aggiunse il dramma delle deportazioni degli ebrei nel 1944, quando l’Ungheria era alleata della Germania nazista.
Péter Pál fu ordinato sacerdote il 28 giugno 1942 e destinato alla parrocchia di Magyarkomját (oggi Veliki Kom’jati), e l’anno successivo si preparò al servizio di cappellano militare. István Pirigyi, che studiò con Péter Pál durante quel periodo di formazione, lo ricorda come una persona benevola, con il volto illuminato da un sorriso gentile e cordiale, un giovane che sapeva rivolgere a ciascuno una parola di conforto o di incoraggiamento e rifuggiva dal formulare giudizi affrettati. Alla sua profonda preparazione teologica e alla sincerità della fede univa un costante anelito verso la santità della vita quotidiana: era un uomo dal temperamento caloroso, dalla disposizione accogliente, dotato di un fascino naturale nei rapporti umani. Conosceva intimamente le pieghe della vita concreta, manteneva una lucida consapevolezza tanto delle questioni che attraversavano la Transcarpazia, quanto delle dinamiche che agitavano lo scenario del mondo. Emil Fircák, insegnante in pensione, se lo ricorda «alto, con i capelli neri, (…) con un tono di voce piacevole, baritonale, (…) con una spilla con l’immagine della Vergine sulla giacca».
Nell’autunno 1944 in quelle regioni arrivò l’Armata Rossa, e la Transcarpazia finì nell’orbita sovietica. Fu allora che nella vita del nuovo beato entrò in gioco un’altra grande figura di sacerdote: il vescovo Teodor Romža. I due si conoscevano bene, poiché Romža era stato guida spirituale e professore di filosofia di Péter Pál durante gli anni del seminario, e nel dicembre 1944 decise di consacrarlo segretamente vescovo (assieme ad Oleksandr Chira) proprio perché, prevedendo le repressioni contro la Chiesa, volle adottare misure preventive per assicurare la linea apostolica perché «non voleva che il gregge rimanesse senza pastore», si legge in una lettera conservata al Russicum1.
Secondo quanto riferito dal canonico István Bendász, Romža era in possesso di un permesso speciale ricevuto dalla Santa Sede con cui, in caso di persecuzione, poteva consacrare vescovi senza previa autorizzazione papale. In tal modo gettò le basi della Hierarchia Occulta, una struttura eparchiale nascosta che avrebbe continuato ad operare per decenni sotto la persecuzione.
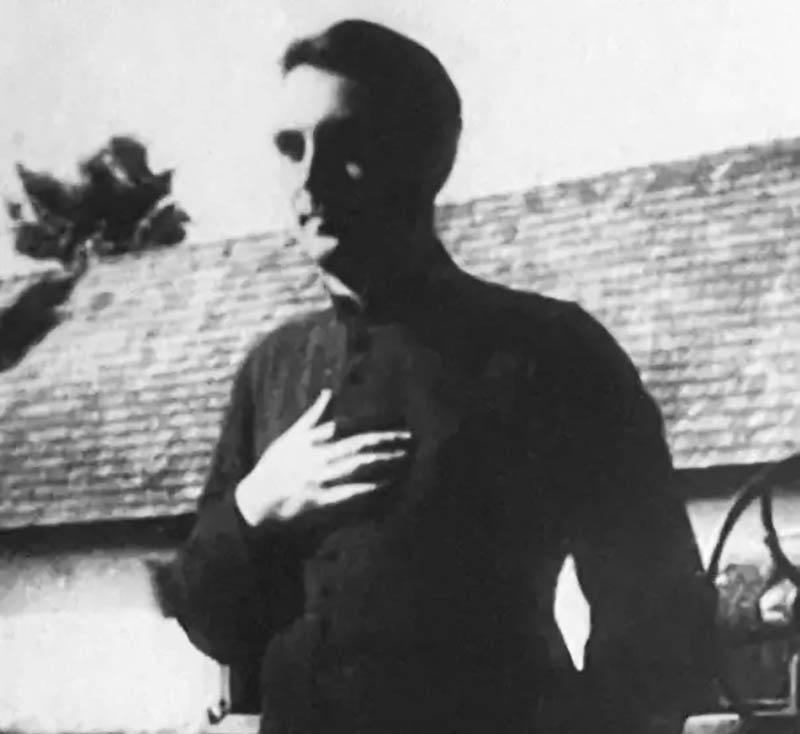
Péter Pál Orosz. (mgce.uz.ua)
L’occupazione militare sovietica portò alla ristrutturazione dell’amministrazione civile e al chiaro intento di liquidare le istituzioni locali fedeli a Roma, in primis la Chiesa greco-cattolica, percepita dal regime come un ostacolo all’assimilazione ideologica e religiosa. Per questo la persecuzione fu immediata e diretta. L’obiettivo era la liquidazione dell’Unione di Užhorod – quel vincolo di comunione con Roma stabilito nel 1646 dai sacerdoti bizantini della regione, pur mantenendo il rito orientale – e l’assorbimento forzato dei fedeli nella Chiesa ortodossa. Già nel marzo del ‘45 Stalin approvò la risoluzione presentatagli da Karpov, presidente del Consiglio per gli Affari della Chiesa, in merito alla creazione di un’eparchia ortodossa a Leopoli e la formazione di un «gruppo di iniziativa» interno alla Chiesa greco-cattolica che proclamasse la rottura con il Vaticano. Questo portò, un anno dopo, al famigerato pseudo-concilio di Leopoli che sancì formalmente la «liquidazione» della Chiesa greco-cattolica ucraina.
E la persecuzione iniziò. Romža nominò Péter Pál vicario parrocchiale del villaggio di Bilky nel giugno 1946, proprio dopo l’arresto del parroco. Nei suoi incarichi pastorali sia a Veliki Kom’jati che a Bilky, il giovane sacerdote manifestò un’attenzione particolare verso le fasce più fragili della popolazione, proprio perché l’esperienza della perdita precoce dei genitori aveva sedimentato in lui una sensibilità specifica verso determinate vulnerabilità, come i bambini senza famiglia o i nuclei numerosi in difficoltà. Non era infrequente che condividesse il proprio pasto con chi frequentava le lezioni di catechismo, o che si privasse di beni personali – scarpe, indumenti – per rispondere a necessità altrui che considerava prioritarie rispetto alle proprie. Questa prassi quotidiana generò intorno alla sua figura una fama popolare fatta di episodi concreti e gesti ripetuti, che ne fecero un sacerdote benvoluto da tutti.
Padre Orosz non si lasciò scoraggiare dalla situazione, e riuscì persino a costruire una nuova chiesa a Veliki Kom’jati, che consacrò il 26 ottobre 1947: un atto che presupponeva, di fatto, l’esercizio di funzioni episcopali. Un anno dopo, il consiglio regionale per gli Affari religiosi convocò i sacerdoti greco-cattolici a Užhorod e comunicò che l’attività della loro Chiesa non sarebbe più stata autorizzata, perciò o passavano all’ortodossia o ne avrebbero pagato le conseguenze legali. L’attività pastorale fu così definitivamente vietata e tutte le chiese greco-cattoliche furono chiuse. Oltre un centinaio di sacerdoti che non vollero passare all’ortodossia furono deportati nei campi di lavoro coatto, dai quali molti di loro non fecero ritorno.
Sfrattato dalla canonica, che fu trasformata in un ufficio del kolchoz, a padre Orosz fu assegnata una stanza in cantina che condivise con un disabile, e fu tenuto costantemente sotto controllo. Quando la polizia cominciò a fermarlo ripetutamente, i fedeli si presero cura di lui alternandosi nell’ospitarlo (si sono conservati i nomi delle meritorie famiglie Izai, Levdár, Sztankó, Pap e Patak). Padre Orosz poté celebrare la messa per l’ultima volta il Giovedì santo del ’49, nella chiesa di Bilky che il giorno dopo venne chiusa. Inizialmente le autorità comuniste volevano demolirla, ma poi cambiarono idea e fu trasformata in Museo dell’ateismo fino al 1989.
Con alcuni confratelli sacerdoti, Péter Pál scelse di operare in clandestinità per i fedeli dei distretti di Iršava e Vynohradiv. Sulle teste dei religiosi pendeva una taglia con ricompensa di 25mila rubli per chi li avesse traditi, e infatti due religiosi nel ’51 furono arrestati e condannati. Dopo l’assassinio del vescovo Romža nel ’47 da parte dell’NKVD, e la condanna di Chira a 25 anni di lager nell’agosto del ’49, Orosz era ormai diventato un punto di riferimento per la Chiesa greco-cattolica dell’intera regione.
Nel maggio 1953, in seguito a delazione, fu catturato nel cortile della famiglia Sztankó e condotto a Užhorod, ma poiché l’arresto era avvenuto dopo la morte di Stalin, a causa della mancanza di chiarezza sulle nuove direttive di politica ecclesiastica fu rilasciato dopo sole due settimane di interrogatori, questa volta condotti senza usare violenza. Gli fu persino promesso che avrebbe potuto lavorare da civile, secondo quanto riferito dallo stesso padre a una conoscente: «Sono libero! Mi hanno detto di farmi rilasciare il passaporto e che potrei lavorare al Charcprom!», ossia l’azienda statale di ristorazione di Char’kov. L’allentamento della politica antireligiosa non durò a lungo: già durante l’estate Orosz scampò ad un attentato, e pochi mesi dopo la sua fotografia circolava nelle stazioni di polizia con un mandato di cattura come «spia americana» da catturare vivo o morto.
Il 27 agosto 1953, alla vigilia della festa della Dormizione, padre Orosz celebrò la liturgia clandestinamente a Veliki Kom’jati. Mentre recitava il rosario in attesa che la sua accompagnatrice Katarina Sztankó comprasse i biglietti del treno per tornare a casa, fu riconosciuto da un operaio che lo denunciò alla milizia e fu arrestato. Mentre lo conducevano al soviet di Zariččja, padre Orosz si fermò davanti a un crocefisso posto su un ponte, si inginocchiò e si rifiutò di proseguire, ma a quel punto l’agente che l’aveva in custodia gli sparò. Il sacerdote morì dissanguato tra le braccia della signora Sztankó. Il corpo fu quindi portato all’obitorio e dopo l’autopsia sepolto frettolosamente in un campo, ma dato che alcuni pastori notarono la scena, venne riesumato nottetempo e trasportato a Iršava dove fu sepolto nel cortile del Dipartimento distrettuale degli Affari interni.
Dopo il ritrovamento della tomba, avvenuto nel 1992, le spoglie di padre Péter Pál furono trasportate nella piccola cappella accanto alla chiesa di Bilky, restituita ai greco-cattolici due anni prima. Le campane di tutti gli insediamenti circostanti suonarono a festa per accompagnare il sacerdote nel suo ultimo viaggio, a 39 anni dalla morte. Nel 2003 è iniziato il processo di beatificazione su iniziativa del vescovo dell’eparchia greco-cattolica di Muchačevo, Milán Šašik.

(youtube)
Nella scheda del Dicastero delle Cause dei Santi leggiamo che da un lato (ex parte victimae) emerge la figura di un uomo di fede incrollabile che resistette alle pressioni per indurlo a passare all’ortodossia e mantenne la fedeltà al Papa, nonostante vivesse costantemente sotto sorveglianza, fosse esposto ad arresti arbitrari e ingiustizie; dall’altro (ex parte persecutoris), il sacerdote era sorvegliato dai servizi segreti in quanto figura influente e stimata nella società, proprio il tipo di persona che il regime voleva eliminare nella sua lotta contro la Chiesa.
Péter Pál Orosz è stato beatificato il 27 settembre scorso a Bilky alla presenza del cardinale Grzegorz Ryś, arcivescovo di Łódź e rappresentante del Papa il quale, al termine della catechesi giubilare, ha chiesto «l’intercessione di questo nuovo beato, affinché ottenga per il caro popolo ucraino di perseverare con fortezza nella fede e nella speranza, nonostante il dramma della guerra».
Il nunzio Kulbokas, al termine della celebrazione, ha voluto collegare la figura del beato all’attualità: «Sappiamo che fuori dall’Ucraina qualcuno potrebbe dire: “Questa guerra è affar loro, che se la sbrighino e decidano da soli”. Immaginiamo di dire la stessa cosa a Gesù Cristo: “Che sia morto sulla croce è un problema tuo, io mi limito a vivere la mia vita”: ecco, diventeremmo persone senza cuore per chi soffre, non saremmo uniti nel cuore a Gesù. Lo stesso vale nei confronti del nuovo beato: se dicessimo “Ha sofferto, ha amato le persone, il suo popolo e la sua Chiesa, ma questa è storia sua, a me servono solo le sue preghiere”, rimarremmo cristiani freddi e falsi, perché il nostro cuore non sarebbe unito al suo. (…) Il secondo aspetto riguarda l’importanza della memoria del beato. Chi lo ricordava? Quei fedeli e sacerdoti che operavano nella clandestinità, e molti di loro sono presenti qui oggi. Perciò se non difendiamo la libertà della Chiesa – che è inseparabilmente unita alla libertà dell’Ucraina – perdiamo anche la memoria della fede. (…) Se vogliamo difendere la nostra fede, dobbiamo difendere tutto: la giustizia e la pace».
(Foto d’apertura: screenshot della liturgia di beatificazione, youtube)
Angelo Bonaguro
È ricercatore presso la Fondazione Russia Cristiana, dove si occupa in modo particolare della storia del dissenso dei paesi centro-europei.
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI