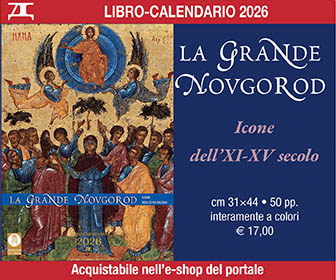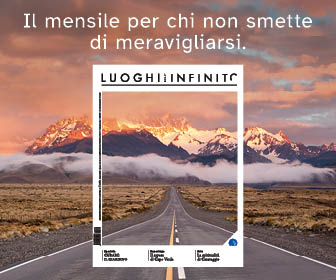14 Dicembre 2024
A proposito di guerra santa
La sacralizzazione della guerra, le prese di posizione dei preti contro la guerra sono i temi cui padre Kordočkin si dedica in questo momento. Torna sempre la domanda: cosa farà la Chiesa alla fine della guerra? (Stralci dall’intervista di Anna Stroganova, Radio France Internationale).
Quando nel febbraio del 2022 fu pubblicata la lettera dei sacerdoti contro la guerra, che anche lei aveva firmato, è rimasto sorpreso dal fatto che fossero così in pochi ad aderire?
Non ho avuto l’impressione che fossero pochi, considerando l’inerzia generale e la generale disabitudine ad andare controcorrente. Non ci ponevamo l’obbiettivo di raccogliere un certo numero di firme. Naturalmente saremmo stati contenti che la gente firmasse, ma la quantità non ci interessava. L’importante era che in quel dato momento la gente sentisse dire dalla Chiesa quello che si aspettava dicesse.
Quella non era la prima lettera aperta. Nel settembre 2019 c’era stata la lettera aperta sul «caso di Mosca» [sottoscritta da 181 sacerdoti per «adempiere al dovere pastorale di intercedere per i prigionieri…», in difesa dei dimostranti arrestati a Mosca, ndt]. Ritenevamo che quanto avevamo detto noi avrebbe dovuto dirlo il patriarca, il Santo Sinodo, avrebbe dovuto uscire sui media del patriarcato. Ma siccome non è uscito da nessuna parte, abbiamo deciso che toccava a noi dirlo. Sentivamo che si aspettava una nostra parola. Non è necessario che la Chiesa parli per via gerarchica, non è il partito comunista. L’importante era in primis che una parola fosse detta, e in seconda istanza che i sacerdoti potessero esprimere la propria solidarietà. Molti, pur approvando la lettera, hanno ritenuto impossibile firmarla. Ma ci sono state delle eccezioni: ad esempio, un sacerdote abbastanza noto ha dichiarato che non avrebbe firmato, pur essendo totalmente d’accordo col contenuto, perché non capiva il senso di firmare una lettera che ovviamente non sarebbe stata ascoltata.
Se è vero che la lettera sul «caso di Mosca» aveva avuto l’effetto di ottenere una riduzione delle pene ed era stata recepita come un impulso di protesta da parte dello strato tradizionalmente leale del clero ortodosso, la lettera contro la guerra non ha fatto registrare alcuna reazione immediata. E tuttavia, non abbiamo ritenuto che la presa di posizione fosse priva di significato, innanzitutto perché la gente si è detta: grazie a Dio, qualcuno ha finalmente detto quello che andava detto.
Ultimamente, mi sto occupando della storia delle Chiese cattolica ed evangelica all’epoca del terzo Reich e nel dopoguerra. Ho ricevuto una borsa di studio della Chiesa evangelica tedesca presso l’Università di Göttingen, il mio lavoro accademico verte sulla sacralizzazione della guerra e le dottrine che hanno portato a definire «santa» la guerra russo-ucraina. E ho constatato che di fatto, la voce della minoranza cristiana in Germania e nell’emigrazione nel dopoguerra è diventata quella dominante. Nel 1945, dopo la fine del conflitto, venne firmata la cosiddetta Dichiarazione di colpevolezza di Stoccarda, nella quale i cristiani riconoscevano la propria responsabilità e la propria colpa.
Questa dichiarazione era stata preceduta, prima ancora dell’inizio della Seconda guerra mondiale, dalla cosiddetta Dichiarazione di Barmen, del 1934: ci furono dei cristiani che già all’inizio di questo orrore denunciarono chiaramente quello che stava accadendo. Quella presa di posizione, ancorché minoritaria, aveva preservato il diritto della comunità cristiana di rivolgersi alla società una volta finita la guerra.
In altre parole, il significato e l’importanza non solo di questa lettera ma in generale di ogni movimento cristiano contro la guerra, per quanto debole o disorganizzato possa sembrare, consiste nel fatto che così preserviamo uno spazio, sia pur piccolo, perché dopo la guerra e dopo Putin la Chiesa possa tornare a rivolgersi alla società con pieno diritto morale.

(https://foto.patriarchia.ru)
L’anno scorso avete creato la piattaforma di sostegno «Pace a tutti», dove pubblicate storie di preti che si sono dichiarati contro la guerra. In questo ambito raccogliete anche soldi per aiutarli a trovare una nuova sistemazione, dato che questi sacerdoti, oltre agli studi in seminario non hanno competenze laiche per poter mantenere la famiglia…
Al concetto di rifugiato politico si è aggiunto oggi quello di rifugiato canonico. Non ricordo che prima della guerra i sacerdoti fossero costretti a lasciare il paese. Se prima il clero incorreva in sanzioni ecclesiastiche non era per ragioni politiche. Oggi invece i canoni vengono usati solo come strumento di repressione politica. I sacerdoti sono sospesi dal ministero solo per aver pubblicamente rifiutato qualcosa che è incompatibile con la dottrina cristiana, come la teoria del Russkij mir, o della guerra santa, che sono in rotta di collisione con i fondamenti del cristianesimo. Il rifiuto pubblico di dare una giustificazione morale al male viene punito non solo dallo Stato, ma anche dalle strutture ecclesiastiche.
Noi diamo vari tipi di aiuto. «Pace a tutti» è nata nel momento in cui abbiamo capito che le repressioni contro il clero stavano diventando sistematiche. Per altro, la piattaforma non puntava solo alla raccolta di fondi. Da un lato cercavamo di mostrare al popolo russo e al mondo che la Chiesa russa non è un monolite, e che il sostegno alla guerra e alla dittatura non è totale. Dall’altro volevamo comunicare a questi preti un senso di solidarietà. Una cosa è vivere a Mosca, e sapere che almeno due o tre altre persone si trovano nella tua stessa situazione, e le puoi incontrare, bere un caffè e pensare insieme come andare avanti. Un’altra è vivere in fondo alla provincia russa, dove non c’è un cane che ti capisca né tra il clero, né tra i vicini, né tra i parenti. Allora è veramente difficile. Volevamo che si sentissero solidali tra loro.
Inoltre, volevamo anche creare una piattaforma per dare voce a questi sacerdoti, in modo che potessero raggiungere la gente. Adesso abbiamo un canale Telegram, e praticamente ogni giorno qualcuno di questi preti propone una breve riflessione, un’omelia o una lezione a partire dal Vangelo, dal santo del giorno o semplicemente da qualcosa a cui tiene. Questa possibilità l’hanno persa quando sono stati sospesi dal ministero o spretati. In più volevamo dare alla gente la possibilità di ascoltare le sane parole di un autentico pastore cristiano. Di tanto in tanto la gente mi scrive che «Pace a tutti» è l’unico filo sottile che la tiene ancora legata alla Chiesa.
Venendo alla sacralizzazione della guerra, come mai ha deciso di studiare proprio questo tema? Come ci è arrivato?
Per due motivi. Nella mia vita ci sono la componente sacerdotale e quella accademica. Prima dell’ordinazione per alcuni anni sono stato in varie università. Quando è iniziata la guerra, penso che tutti abbiano cercato qualche modo personale per sopravvivere emotivamente e psicologicamente, per me uno strumento è stato cercare di capire cosa stava accadendo. Secondo me anche le forme più terribili e irrazionali dell’umano comportamento si possono analizzare e capire.
Inoltre, quando la gente ha cominciato a riflettere seriamente su come fermare la guerra, si è resa conto che non si può fermare una cosa che non si capisce. Naturalmente molti, anche tra l’opposizione russa, dicono che Putin si può fermare solo sul campo di battaglia, e che l’unico modo di opporsi al regime putiniano è sostenere le forze armate ucraine.
Padre Kirill Hovorun, che ha riflettuto molto sulla questione, ripete spesso che in ogni guerra ci sono due elementi principali: le armi e le idee. Le armi non sparano e non funzionano senza le idee.
Essendo un cristiano e un sacerdote, non voglio seguire una strada che moltiplica le morti, per questo ritengo che il mio contributo alla cessazione della guerra potrebbe essere de-costruire le idee che a molti sembrano chiare e semplici, e che invece sono dottrine artificiose create da certe persone per uno scopo preciso, come quelli che fanno il gioco delle tre carte per la strada.
Come fermare le persone che sono rimaste impigliate nel gioco? Bisogna capire in che modo le imbrogliano e spiegarglielo. Cosa non sempre facile. Come diceva Puškin: «Oh, ingannarmi non è difficile! Son io che lo voglio!». Se uno vuole farsi imbrogliare è molto difficile farlo smettere, ma almeno bisogna provarci.
Questa evoluzione della Chiesa ortodossa russa, che è arrivata a sostenere apertamente la famosa «guerra santa», secondo lei era logica e prevedibile?
Al principio erano i fautori della guerra a domandarci: dove eravate negli ultimi otto anni? Adesso, la stessa domanda ce la fanno gli oppositori della guerra. Sicuramente nella Chiesa sono avvenute cose che mi inquietavano, che non potevo accettare. E lo dicevo pubblicamente; ho pubblicato dei testi… Ho scritto un libro che si intitola A Cesare quel che è di Cesare. Il cristiano dev’essere un patriota?, in cui parlavo dell’atteggiamento del cristiano verso lo Stato. Forse è stato il primo tentativo in lingua russa di affrontare criticamente il concetto di patriottismo, che generalmente è accettato dalla maggioranza come una cosa ovvia.
Nel libro della studiosa russa Ljudmila Brovko, La Chiesa e il Terzo Reich, l’autrice osserva che per i tedeschi prima, durante e dopo la guerra, il patriottismo fu il tallone di Achille, da una parte rese loro possibile accettare la dottrina dello Stato, e dall’altra gli rese difficile poi riconoscere la propria colpa e responsabilità alla fine della guerra. Infatti, dicevano: «Noi stiamo col nostro paese, non siamo dei traditori! Come si può fare altrimenti mentre i nostri ragazzi muoiono sul fronte orientale?». È chiaro che il tema del patriottismo è particolarmente sensibile in qualsiasi paese in guerra. Persino gli USA non facevano eccezione durante la guerra del Vietnam. Ma certe volte tutto questo può assumere forme morbose.
Occorre capire che persino la nostra Chiesa istituzionale segue una certa dinamica. Quando Putin parlò all’Assemblea Federale per annunciare l’annessione della Crimea, il patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ non era presente. Evidentemente capiva che la vicenda avrebbe provocato una certa tensione tra i fedeli ortodossi in Ucraina…
Eppure, anche se io, come molti, vedevo il pericolo e pensavo che se ne dovesse parlare, in fondo lo avevo sottovalutato. Quel che è successo il 24 febbraio 2022 per me è stato un colpo, come per molti altri. Ora, guardando indietro, considerando il lungo processo di militarizzazione della società, tutte quelle divise sin dai bimbi in fasce, il dilatamento isterico del militarismo, risulta evidente dove stavamo andando a finire.

(https://foto.patriarchia.ru)
Lei, da studioso, come definirebbe la Chiesa ortodossa russa di oggi, sotto la guida del patriarca Kirill?
Quando usiamo la parola «Chiesa» bisogna stare molto attenti. Da una parte la Chiesa esiste come istituzione sociale con le sue strutture, i suoi dipartimenti sinodali, i suoi portavoce. Dall’altro, quando noi credenti confessiamo la nostra fede nella Chiesa, non crediamo in un partito, in una struttura, o nel suo management, ma in una comunità di persone con punti di vista e valutazioni molto diversi su ciò che accade.
Se parliamo dell’istituzione, la situazione è sicuramente molto grave. La posizione della Chiesa in Unione Sovietica assomigliava in un certo senso a quella della Chiesa cattolica in Germania sotto il Terzo Reich. La Chiesa, pur di preservare le strutture ecclesiastiche, aveva accettato alcuni compromessi con lo Stato, senza mai assumere come sua la dottrina dello Stato.
Oggi noi osserviamo un quadro diverso. Infatti, non si tratta di un compromesso con l’ideologia di Stato, ma del fatto che è la Chiesa istituzionale a generare in gran parte questa ideologia. Quando dicono che la Chiesa è diventata uno strumento, io rispondo che è una semplificazione. Non si tratta del rapporto tra soggetto e oggetto. Parliamo di una comunità di persone, all’interno delle strutture ecclesiastiche o governative, che pensa rigorosamente allo stesso modo.
Stiamo parlando di una setta apocalittica totalitaria che crede di aver un valore superiore e che l’esistenza del mondo non abbia significato al di fuori di essa. E se si può dire che la Chiesa in Unione Sovietica o in Germania ha accettato certi compromessi con lo Stato, il quale da parte sua era in grado di generare da sé la propria ideologia, adesso vediamo che è la Chiesa a fornire il carburante ideologico per la guerra, con la dottrina della guerra santa in quanto tale. Non semplicemente della guerra giusta come male inevitabile, ma proprio della guerra santa. La Chiesa istituzionale ha in questo una pesante responsabilità.
Quando la guerra sarà finita e il regime politico messo fuori gioco, la Chiesa istituzionale cadrà sicuramente in una profondissima crisi. Il periodo sovietico è stato il tempo del bipensiero. Oggi in generale il bipensiero non esiste. I nostri Z-predicatori credono sinceramente in quello che dicono.
Per questo sarà ancora più difficile per loro in futuro, sia nei confronti di Dio che nei confronti della gente.
Parlando del futuro, quali possono essere, secondo lei, gli sviluppi possibili?Innanzitutto, subentrerà un enorme calo di fiducia nei suoi confronti e una perdita di autorevolezza. È evidente che quando una Chiesa si lega a un regime politico subirà le conseguenze della sua caduta. In un certo senso è quanto avvenne in Russia dopo il 1917. È quanto è avvenuto (forse in maniera molto più soft) in Spagna, dove la Chiesa cattolica è considerata da molti come un relitto dell’epoca franchista. Al tempo stesso, è chiaro che nella comunità ecclesiale si svilupperanno inevitabilmente le stesse tendenze della società. Se parliamo delle repressioni ecclesiastiche, la cosa si verifica perché la stessa cosa avviene nello Stato.
Se lo Stato cambierà, se dovesse diventare più orizzontale, se si affiderà più alla libertà e alla responsabilità umana che all’obbedienza cieca e irragionevole, è evidente che gli stessi processi avverranno anche nella Chiesa, magari un po’ più lentamente. Ma non è il caso di fare gli idealisti: le idee putiniane permarranno ancora a lungo nella comunità ecclesiale.

(https://foto.patriarchia.ru)
Il paragone con il Terzo Reich è corretto rispetto al presente?
Penso che sia corretto in relazione al presente. Cerco di elencare le somiglianze e le differenze che vedo. Se parliamo delle somiglianze, certamente ci sono nell’ideologia. C’è la parola tedesca Sonderweg o via speciale. La via speciale dei tedeschi somiglia molto all’«idea russa», che poi è degenerata nel «mondo russo» e, alla fine, nella fede nella natura messianica del popolo russo.
E poi ancora la retorica della grandezza e superiorità nazionale, il rifiuto della democrazia liberale, il culto della morte eroica, l’idea che il potere ha una natura spirituale data dall’alto, l’ideologia della «fortezza assediata» eccetera. Umberto Eco parlava anche della persecuzione di tutti gli atteggiamenti sessuali nonconformisti, dalla castità all’omosessualità, come di un importante indicatore del fascismo. Io ho detto spesso che Aleksandr Dugin ha importato in Russia le concezioni politiche della Germania degli anni ’30-40. Lo stesso Dugin è la quintessenza del fascismo allo stato puro, e il fatto che oggi vada per la maggiore non è casuale.
Se parliamo di differenze, in questo caso non giocano a nostro favore. La prima e, direi, principale differenza sta nel fatto che la società tedesca, alla presa del potere dei nazional-socialisti, restava fondamentalmente tradizionale e cristiana, a differenza di quella post-sovietica. Secondariamente, i cambiamenti radicali avvenuti nella società tedesca, tra i cristiani tedeschi, sono avvenuti sotto l’occupazione straniera, scenario poco probabile per la Russia, escludendo un conflitto atomico globale. La terza differenza è quello che ho già citato, nel Terzo Reich la Chiesa non generava l’ideologia, a differenza della Chiesa ortodossa russa.
Infine, il movimento della resistenza tra i cristiani tedeschi era più organizzato e aveva delle forme più visibili che il nostro adesso. In Germania esisteva la cosiddetta «Chiesa confessante», che di fatto fu all’opposizione del governo sino alla fine della guerra. Mentre è abbastanza difficile parlare di una resistenza visibile e sistematica al putinismo all’interno della Chiesa russa.
Questo fa sì che sia ancora più importante quello che noi cerchiamo di fare, e per il quale abbiamo creato «Pace a tutti». Noi, mi sembra, stiamo cercando di creare un nuovo linguaggio per esprimere il presente, una lingua con la quale la Chiesa potrà rivolgersi alla società dopo la guerra, anche là dove non dovesse parlare da una posizione di forza, o a nome della maggioranza, perché è ovvio che non siamo la maggioranza.
È un dato di fatto che la società russa, ancorché si usi parlare di rinascita religiosa, continua ad essere in maggioranza atea. Inoltre, abbiamo capito che il cosiddetto «entrare nella Chiesa» non significa affatto che uno diventa cristiano e capisce cos’è il cristianesimo. In Russia il cristianesimo è senz’altro vivo, ma è la religione di una minoranza.
Vuol dire che questa nuova lingua in realtà è quella vecchia ben dimenticata? È il ritorno al Vangelo, ai fondamenti del cristianesimo?
Sicuramente, è il ritorno al Vangelo e semplicemente ai concetti base dell’umanesimo, che non possono essere professati da posizioni di superiorità: «Dateci ascolto, perché noi siamo meglio di voi». A ben vedere, anche la lettera dei sacerdoti contro la guerra non era scritta da gente che parla dall’alto in basso. Se vogliamo essere ascoltati, dovremo abbandonare l’arroganza e il paternalismo.
(fonte: RFI)
(foto d’apertura: elaborazione elettronica da https://foto.patriarchia.ru)
Andrej Kordočkin
Nato a Leningrado, ha studiato teologia a Oxford. In seguito, è stato parroco per 18 anni della chiesa di Santa Maria Maddalena a Madrid e cappellano nelle carceri spagnole. All’inizio della guerra in Ucraina, ha firmato l’appello dei sacerdoti della Chiesa ortodossa russa per la cessazione del conflitto. Sospeso a divinis per tre mesi nel 2023, si è dimesso ed è passato al patriarcato di Costantinopoli. Oggi è parroco della comunità ortodossa di Tilburg, in Olanda. È tra gli organizzatori del progetto «Pace a voi», che aiuta i sacerdoti del patriarcato di Mosca in difficoltà per le loro posizioni a favore della pace.
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI