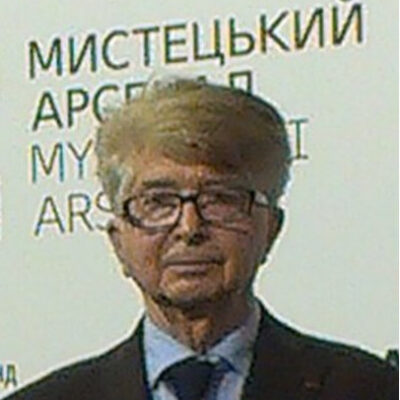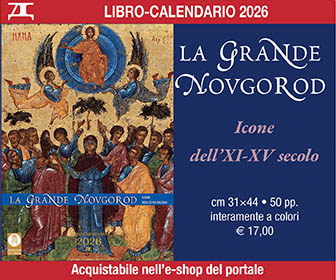13 Settembre 2025
Nella mia vita la Russia «assente e presente»
Decano e maestro degli slavisti europei, il professor Nivat il 25 agosto scorso ha tenuto un memorabile discorso davanti all’assemblea plenaria del XVII Congresso mondiale degli slavisti, a Parigi. Per condividere il suo amore sofferto per la Russia e le nuove scoperte.
Signore, signori, cari colleghi, scusate ma vorrei dare alla mia allocuzione un taglio personale. Il luogo stesso, questa assemblea, la mia età lo esigono.
I miei primi contatti con la Russia e la lingua russa sono avvenuti grazie a degli emigrati.
Il primo era tedesco, rifugiato da Tilsit [in Prussia orientale, occupata dai sovietici nel 1945 – ndr]. Ci conoscemmo nel 1950 a Francoforte sul Meno, dove trascorsi alcuni mesi. Mi lesse l’ultimo racconto del terzo Tolstoj [Aleksej Tolstoj, 1883-1945 – ndr], Il carattere russo. Così imparai subito che nei russi il patetico prevale sulla verità.
(Immagine d’apertura: fotoload).
La lettura dell'articolo completo è riservata agli utenti abbonati, effettua l'accesso o abbonati per accedere a tutti i contenuti del sito.
Georges Nivat
Accademico, slavista e traduttore francese. Dopo l’École normale supérieure, ha conseguito la laurea in russo alla Sorbona. È stato professore in varie università e dal 1990 è membro dell’Academia Europaea di Cambridge. Ha al suo attivo una produzione scientifica sterminata, nella quale si segnala tra l’altro la cura (insieme a E. Etkind, I. Serman e V. Strada) di una monumentale Histoire de la littérature russe, parzialmente tradotta in italiano da Einaudi.
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI