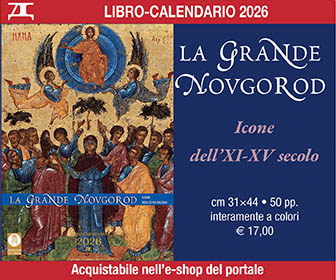2 Ottobre 2025
Il problema nazionale: la voce profetica di Solov’ëv
Quasi 150 anni fa la voce dissonante di Solov’ëv si alzava per richiamare l’attenzione sul problema nazionale. La limpidezza del suo pensiero può essere guida e ispirazione anche oggi.
Iniziamo a riproporre in prima traduzione italiana un testo fondamentale – e quanto mai attuale – del grande filosofo Vladimir Solov’ev. Il «problema nazionale», allora come oggi, è chiave di lettura della storia e della cronaca politica. Questo testo venne pubblicato per la prima volta nel gennaio del 1883. Alla sua uscita, il capitolo qui presentato aveva un’apertura diversa, anch’essa pregnante: «la grande controversia dell’Oriente e dell’Occidente attraversa tutta la vita dell’umanità. (…) Nata prima del cristianesimo, interrotta per un certo tempo dalla nuova religione, e poi nuovamente ripresa dalla politica anti-cristiana in seno allo stesso mondo cristiano, questa sciagurata controversia può e deve essere definitivamente superata da una politica autenticamente cristiana», e Solov’ev la supera trascendendo radicalmente il piano puramente politico, per andare all’essenziale: il cuore della vita.
I PARTE
La completa separazione tra morale e politica è uno degli errori e dei mali prevalenti della nostra epoca. Dal punto di vista cristiano e all’interno del mondo cristiano, questi due ambiti, quello morale e quello politico, pur non potendo coincidere, devono essere intimamente connessi tra loro.
(Traduzione e cura di Adriano Dell’Asta)
1 – continua
(Immagine d’apertura: Edward Lear, Ibreem; wikimedia).
La lettura dell'articolo completo è riservata agli utenti abbonati, effettua l'accesso o abbonati per accedere a tutti i contenuti del sito.
Vladimir Solov’ëv
Vladimir Solov’ëv (1853-1900) è uno dei filosofi russi più importanti di tutti i tempi. In lui sono già presenti, a livello di sistema, tutte le idee che saranno all’origine della rinascita spirituale russa dell’inizio del XX secolo. Tra le sue opere ricordiamo: La Russia e la Chiesa universale, La crisi della filosofia occidentale» e «Islam ed ebraismo».
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI