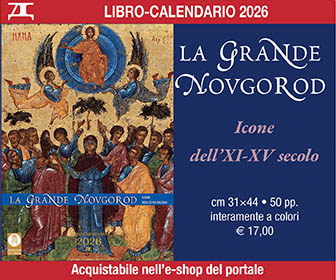16 Agosto 2025
«Nel battito ardente del suo cuore». In memoria di Dmitrij Šostakovič
Cinquant’anni fa moriva Dmitrij Šostakovič. Un artista poliedrico, costretto al compromesso dal regime di Stalin, ma sempre fedele alla sua musica e amante della libertà di creazione. Lo ricordiamo con le parole della pianista Marija Judina. (A cura di Alessandra Belloli).
Il 9 agosto del 1975, cinquant’anni fa, moriva a Mosca Dmitrij Šostakovič. La sua personalità fu così geniale che divenne quasi impossibile da inquadrare: considerato una figura controversa, da alcuni venne accusato di conformismo, altri invece lo ritennero un esempio di resistenza morale.
Infatti, come tutti gli artisti russi che ebbero in sorte di vivere gli anni del Grande Terrore, Šostakovič fu costretto al compromesso tra la sopravvivenza e la libera creazione. A quest’ultima, il compositore non era disposto a rinunciare: per questo suo desiderio di libertà venne sempre considerato dal regime un elemento estraneo, da tenere d’occhio, perché la sua musica, anche quella composta su commissione del governo, aveva un respiro più ampio del ristretto canone socialista.
Lo ricordiamo con le parole che la pianista e amica Marija Judina scrisse per il suo sessantesimo compleanno e che pubblicò sulla rivista «Moskovskij komsomolec».
La lettura dell'articolo completo è riservata agli utenti abbonati, effettua l'accesso o abbonati per accedere a tutti i contenuti del sito.
Marija Judina
Nata nel 1899, insegnò al conservatorio di Leningrado e fu protagonista di numerose battaglie per la libertà della Chiesa e dell’arte. Fu lasciata ai margini della cultura ufficiale, visse di stenti e rimase sconosciuta ai più in Occidente. Morì nel 1970.
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI