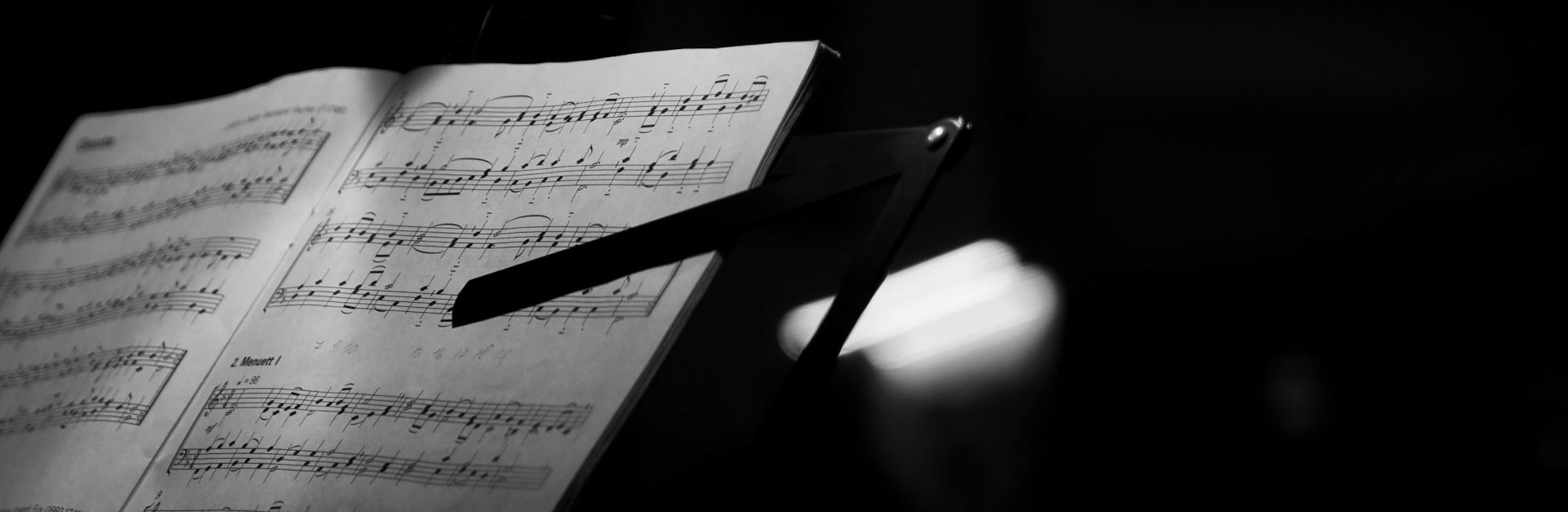
7 Novembre 2025
La resistenza nella musica: Arvo Pärt e Valentin Sil’vestrov
In Francia è uscito un libro di Konstantin Sigov che delinea i percorsi incrociati di due grandi compositori del XX secolo, l’estone Arvo Pärt e l’ucraino Valentin Sil’vestrov. La loro ricerca di una nuova forma musicale è stato il modo per liberarsi dal nichilismo ideologico che disprezza e teme la forma.
Chi ha paura del formalismo? «La forma non è più la “sorella gemella” della libertà, ma piuttosto il suo nemico giurato». Antoine Garapon ha lanciato questa tesi provocatoria poco prima della chiusura del suo programma «Esprit de justice», che è andato in onda per oltre vent’anni su France Culture. Nel suo programma «Che cosa significa il trumpismo?» ha sintetizzato in questi termini la tendenza delle ideologie che hanno preso il potere negli Stati Uniti e che si stanno diffondendo in Europa: «Un tratto che sembra accomunare tutte queste ideologie è lo stesso disprezzo per le forme… Il diritto e le istituzioni sono percepiti come ostacoli alla “vera” democrazia; ogni forma è vissuta come un “espediente giuridico”…».
(Immagine d’apertura: Kirsten Kluge/Unsplash).
La lettura dell'articolo completo è riservata agli utenti abbonati, effettua l'accesso o abbonati per accedere a tutti i contenuti del sito.
Konstantin Sigov
Docente di storia delle idee teologiche e filosofiche all’Università statale Accademia Moghiliana di Kiev, dirige il Centro di ricerche umanistiche europee. Nel 1992 ha fondato l’Associazione culturale ed editoriale «Duch i litera», di cui è direttore.















