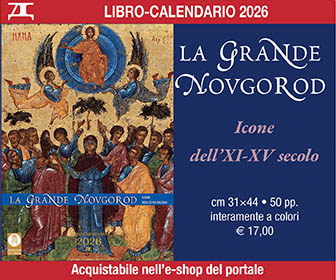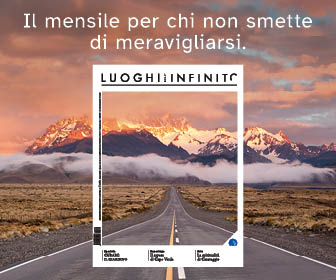6 Agosto 2025
L’uomo che scolpiva l’Uomo
Il centesimo anniversario della nascita di Ernst Neizvestnyj ci offre l’occasione per riscoprire la figura di un artista che ha espresso con l’arte e la vita una forte passione per l’Uomo e la sua complessa libertà. Il suo ultimo augurio ai russi.
Lo scultore Ernst Neizvestnyj nasce nel 1925 a Smolensk (l’attuale Ekaterinburg) da padre chirurgo e madre scienziata. La sua carriera segue in apparenza i canoni dell’ideale sovietico: frequenta l’esclusiva scuola d’arte di Leningrado e si arruola volontario a soli 17 anni nelle truppe scelte ai diretti ordini di Stalin. Gravemente ferito in guerra, viene dato per morto, alla madre arriva la notifica del decesso e riceve «postumo» l’ordine della Stella Rossa.
(Immagine d’apertura: monumento la Maschera del dolore a Magadan, wikipedia)
La lettura dell'articolo completo è riservata agli utenti abbonati, effettua l'accesso o abbonati per accedere a tutti i contenuti del sito.
Miriam Zanoletti
Nata nel 1999, ha studiato all’Università Ca’ Foscari di Venezia e Albert-Ludwig di Friburgo, conseguendo la laurea magistrale in Lingue e Letterature tedesca e russa.
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI