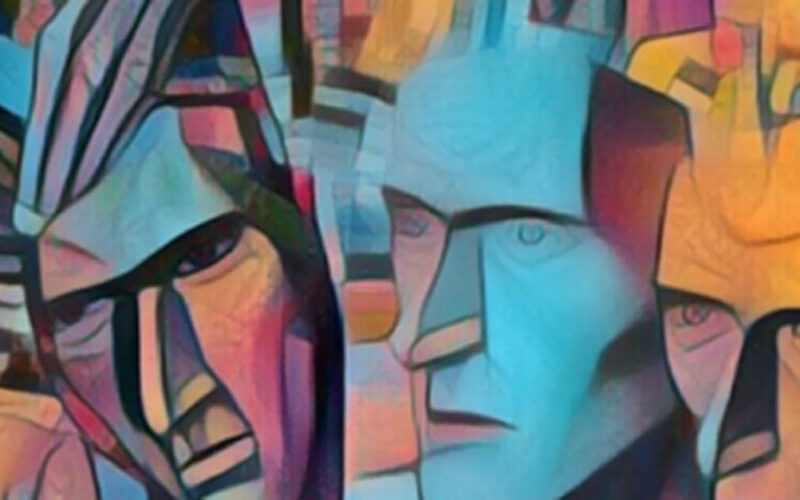- HOME /
- ARTICOLI /
- 2025 /
- Recensioni /
- Tatari di Crimea: un popolo irriducibile
4 Marzo 2025
Tatari di Crimea: un popolo irriducibile
Recensione al libro di M. Buttino “I tatari di Crimea. Dalla deportazione al difficile ritorno. 1944-2024”. La storia di un popolo che sembra non potersi liberare da un destino di negazioni e di persecuzioni, la cui memoria dovrebbe essere cara a tutti gli uomini liberi.
Ci sono popoli ricchi di storia e di tradizioni, con un’identità forte e riconosciuta, che sembrano non potersi liberare da un destino di negazioni e di persecuzioni; i tatari di Crimea sono uno di questi popoli, la cui memoria dovrebbe essere cara a tutti gli uomini liberi. Ben venga, dunque il libro di Marco Buttino, I tatari di Crimea. Dalla deportazione al difficile ritorno. 1944-2024 (Scholé Morcelliana, Brescia 2024).
L’autore – uno dei massimi esperti della storia della Russia e dell’Asia centrale e delle trasformazioni che queste regioni hanno conosciuto dall’epoca zarista ai giorni nostri – ricostruisce le vicende dei tatari di Crimea, partendo dalla deportazione in epoca staliniana, passando poi al loro contrastato ritorno con la fine del dominio sovietico, per finire da ultimo con il loro difficile presente nella situazione che si è creata dopo l’annessione russa del 2014 e la successiva invasione dell’Ucraina da parte della Russia putiniana.
È una storia ormai quasi secolare, segnata dal perpetuarsi di «politiche autoritarie» e qui ripercorsa utilizzando come punto di osservazione la comunità tatara di Samarcanda, che era finita in Uzbekistan proprio in seguito alla tragedia scatenata da Stalin il 18 maggio 1944. Quel giorno, il dittatore georgiano iniziò una delle grande operazioni di ingegneria sociale che lo portarono a trasferire forzatamente da una parte all’altra dell’Unione Sovietica intere popolazioni (oltre ai tatari, polacchi, coreani, finlandesi, baltici, tedeschi del Volga, ceceni, ingusci, turchi mescheti, ecc.), unicamente sulla base della loro appartenenza a un determinato ceppo etnico e al sospetto mai provato che queste popolazioni, nel loro complesso e in quanto tali, fossero nemiche dello Stato (diciamo semplicemente: inadatte alla sua edificazione secondo gli schemi e le rappresentazioni dell’ideologia sovietica).
Nel caso dei tatari, l’accusa era quella di collaborazionismo con l’invasore nazista: nel giro di tre giorni (secondo quella che oggi è la tanto decantata efficienza staliniana) la vita di circa 200.000 persone venne sconvolta dall’operazione; si trattava di intere città e villaggi, i cui occupanti vennero collettivamente investiti da questa accusa, tanto più assurda in quanto questi gruppi erano composti nella loro stragrande maggioranza da giovani, vecchi e donne (molti dei maschi adulti erano già morti in guerra o erano già stati fucilati preventivamente).
Il successivo trasferimento avvenne in condizioni tremende che causarono un’elevata mortalità; come precisa Buttino: «Le dimensioni dello sterminio sono, in ogni caso, impressionanti e giustificano il fatto che, al di là della correttezza giuridica del termine, si parlerà della deportazione come genocidio». Le condizioni di questa povera gente non migliorarono neppure all’arrivo nei centri di destinazione; come ci testimoniano oggi documenti stilati dalle stesse autorità sovietiche del tempo, nulla era stato preparato e i deportati «si dovettero arrangiare a vivere per mesi senza un tetto sopra la testa».
Poi, la grande intraprendenza di queste popolazioni e la loro capacità di ritrovare rapidamente legami di solidarietà familiare ed etnica fecero sì che la vita potesse riprendere; e abbiamo allora quanto ci viene descritto nella parte centrale di questo libro sulla base di tante storie personali.
Con la ripresa di una sia pur relativa normalità e con la morte di Stalin il problema delle origini e dell’appartenenza tornò però a farsi sentire e iniziò un nuovo capitolo, decisamente meno tragico, ma ugualmente pesante, quello della rivendicazione dei diritti violati e della riproposizione di una verità che l’ideologia non riusciva più a nascondere; l’idea che lo Stato potesse sempre decidere cosa fosse meglio per il singolo e che questo dovesse comunque piegarsi al fatto compiuto era ormai qualcosa di totalmente inaccettabile.
Il fatto che oggi questa impostazione possa invece essere riproposta in tanti discorsi correnti (che si tratti della Palestina o dell’Ucraina) dovrebbe essere oggetto di attenta riflessione da parte di ciascuno di noi e comunque sarebbe apparso allora incredibile; questa diversa sensibilità diede così vita a una delle pagine più interessanti e luminose del dissenso sovietico, quella del movimento per il ritorno dei tatari di Crimea nelle loro terre d’origine.

Il generale Pëtr Grigorenko (wikipedia).
Lettere, telegrammi, petizioni con migliaia di firme segnarono una svolta decisiva, con persone la cui identità e unicità erano state negate e che ora si rifacevano vive, rivendicando il rispetto dei diritti umani di base «in modo aperto, non clandestino» e riproponendo la propria esistenza con una decisione in cui il soggetto e la sua responsabilità trovavano una riaffermazione sorprendente.
La risposta del potere fu immediata, con arresti e condanne (il primo processo venne celebrato a Taškent nell’ottobre del 1961) e con la resistenza irriducibile di un popolo e di alcuni suoi portavoce, come Mustafa Džemilev (1943) che da allora iniziò una lotta mai interrotta (con ripetuti arresti e condanne), o sostenitori esterni, come Pëtr Grigorenko (1907-1987), generale dell’Armata Rossa, di origini ucraine, che si dedicò con particolare abnegazione alla causa tatara.
Tutto questo movimento può sembrarci oggi normale ma, giustamente, Buttino fa notare come non fosse mai esistito prima nulla di simile: «In URSS non esistevano movimenti sociali analoghi, né vi erano altre forme di organizzazioni autonome in grado di perpetuare la protesta nonostante la repressione. I tatari stavano aprendo spazi inediti di democrazia». E furono spazi reali e fecondi.
Alla fine, movimenti come il dissenso, il contemporaneo risvegliarsi delle tendenze centrifughe tra i vari popoli dell’Unione Sovietica e la crisi sistemica del mondo sovietico portarono al crollo del regime; e la vita sembrò poter riprendere, con dinamiche diverse, certo, (ritorno in patria, assimilazione nelle nuove patrie, ecc.), ma normalmente determinate dall’interazione tra le condizioni sociali e la libertà delle persone e non certo decise dal potere centrale.
Poi, di nuovo, tutto è mutato; con l’annessione del 2014 e la successiva guerra, presente e futuro nuovamente sono stati sconvolti da una nuova operazione, «l’operazione militare speciale» che ribadiva la politica affermata da Putin «da quando era diventato presidente della Russia: ricostruire l’Impero poggiando sulle minoranze russe dei paesi vicini. Dopo l’invasione della Georgia, avvenuta sei anni prima, il Donbas e la Crimea erano ora i luoghi in cui applicare la nuova dottrina», e dove riprendere le persecuzioni interrotte ai tempi dell’Unione Sovietica: il destino di Mustafa Džemilev, da questo punto di vista, è incredibilmente simbolico, con una persecuzione attuale che riprende quella sovietica.

Mustafa Džemilev al senato polacco nel 2014 (wikipedia).
Come uscire da questa situazione è questione la cui difficoltà è sotto gli occhi di tutti, con un’alternativa democratica che è ancora tutta da costruire «al di là delle contrapposizioni nazionali», ma che certo, come viene sottolineato più volte nel libro, non potrà prescindere dalla conservazione della «memoria collettiva dei tatari» e, da parte del mondo libero, dalla sua irrinunciabile difesa.
(Immagine d’apertura: Wikipedia)
Adriano Dell’Asta
È docente di lingua e letteratura russa presso l’Università Cattolica. Accademico della Classe di Slavistica della Biblioteca Ambrosiana, è vicepresidente della Fondazione Russia Cristiana.
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI