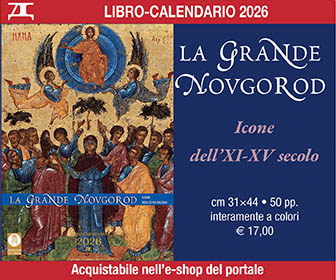14 Maggio 2025
Padre Malecki, il don Bosco di Pietroburgo
Monsignor Antoni Malecki, grande educatore di ragazzi abbandonati a Pietroburgo e pastore irriducibile durante la rivoluzione russa. La sua sofferenza è stata quella di vedere dispersi i propri figli. Si sta per aprire la causa di beatificazione.
Nella lista dei martiri della Chiesa cattolica russa c‘è anche monsignor Antoni Malecki, grande educatore, noto anche come «il don Bosco di San Pietroburgo», che dal 1926 fu amministratore apostolico di Leningrado (nome di San Pietroburgo dal 1924 al 1991 – nda).
(Immagine d’apertura: Monica Volpin, pixabay.com)
La lettura dell'articolo completo è riservata agli utenti abbonati, effettua l'accesso o abbonati per accedere a tutti i contenuti del sito.
Olivier Peyron
Nato nel 1973, sacerdote della diocesi di Valence. Ha studiato storia e scienze politiche e successivamente al seminario francese a Roma. Dottore in scienze ecclesiastiche orientali presso il Pontificio Istituto Orientale, insegna all’Università Cattolica di Lione ed è postulatore della causa dei martiri russi.
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI