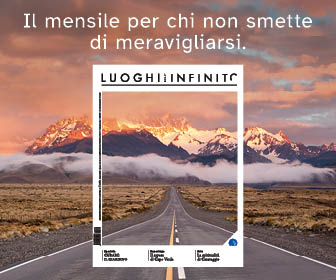27 Luglio 2025
Helsinki 1975: un fragile seme che ha dato frutti di libertà
Cinquant’anni fa la firma degli Accordi di Helsinki fu un momento cruciale per la distensione e la cooperazione tra Est e Ovest. Le clausole sui diritti umani, che l’URSS considerava una formalità, divennero la base legale per le rivendicazioni dei movimenti del dissenso.
Dal punto di vista politico, i primi quarant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale furono determinati fondamentalmente da due fenomeni: l’esistenza di un mondo bipolare diviso e il successivo scioglimento del blocco sovietico.
(foto d’apertura: la firma dell’Atto finale, fordlibrarymuseum.gov)
La lettura dell'articolo completo è riservata agli utenti abbonati, effettua l'accesso o abbonati per accedere a tutti i contenuti del sito.
Angelo Bonaguro
È ricercatore presso la Fondazione Russia Cristiana, dove si occupa in modo particolare della storia del dissenso dei paesi centro-europei.
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI