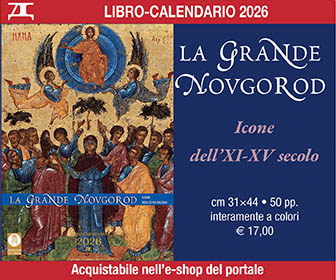25 Settembre 2025
Da Nicea a Iznik
Alcune riflessioni ecumeniche nell’anniversario del concilio di Nicea. Al cuore di quel concilio tre compiti essenziali per la Chiesa: la pienezza della fede, la sinodalità di governo, la celebrazione comune della Pasqua. Compiti da assumere anche oggi.
Il concilio di Nicea del 325 viene spesso riassunto in tre aspetti: la proclamazione del simbolo della fede, l’inaugurazione della pratica sinodale come stile di governo nell’intera Chiesa, la determinazione di una data comune per celebrare la Pasqua. Fede, governo, liturgia: ritroviamo qui i tre compiti fondamentali della Chiesa che riflettono i tre «uffici» di Cristo (le tria munera): l’insegnamento (munus docendi), il governo (munus regendi), la celebrazione (munus celebrandi), a cui corrisponde la triplice unzione profetica, regale e sacerdotale che ogni cristiano riceve nel battesimo. A questi tre aspetti corrispondono anche tre termini su cui vorremmo soffermarci per riflettere sulle prospettive ecumeniche aperte dal 1700° anniversario del concilio di Nicea: il simbolo, il sinodo, la sinassi.
(Foto d’apertura: S. Sofia di Iznik – Dosseman, wikipedia, CC BY-SA 4.0)
La lettura dell'articolo completo è riservata agli utenti abbonati, effettua l'accesso o abbonati per accedere a tutti i contenuti del sito.
Hyacinthe Destivelle
Rev.do P. Hyacinthe Destivelle, OP, officiale della Sezione orientale del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani.
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI