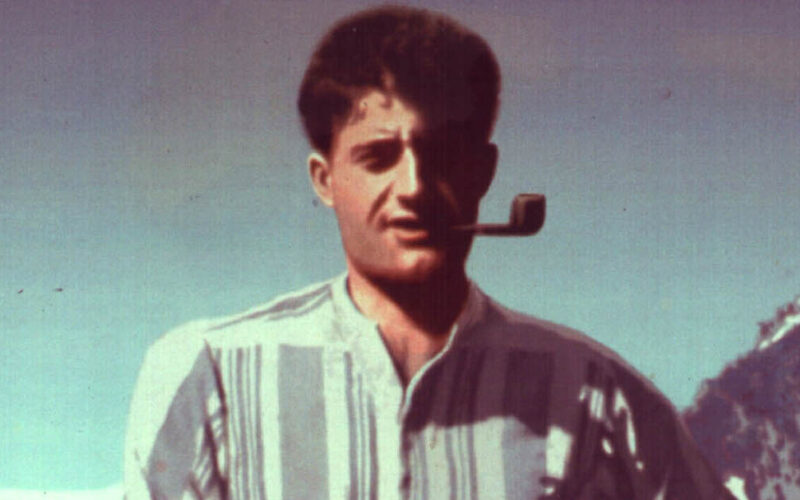- HOME /
- ARTICOLI /
- 2025 /
- Percorsi della memoria /
- Ritrovare la persona dietro l’etichetta
20 Novembre 2025
Ritrovare la persona dietro l’etichetta
L’esperienza di convivenza e di conflitti nazionali vissuta in Cecoslovacchia nel ‘900 e i passi di riconciliazione fatti ci ricordano una possibile via d’uscita dalle chiusure ideologiche mentre aumentano le narrazioni nazionaliste.
Nel cuore dell’Europa centrale, all’inizio del ‘900, esisteva una realtà che oggi faticherebbe a trovare posto nelle narrazioni nazionaliste: famiglie miste in cui padre e madre parlavano lingue diverse, città trilingui come Bratislava, in cui convivevano tedeschi, cechi, slovacchi, ungheresi ed ebrei. Il testimone Otto Sobek si chiede «non ci rendevamo conto di cambiare lingua, era normale rispondere in base a quella in cui ti interpellavano».
(immagini generate con IA)
La lettura dell'articolo completo è riservata agli utenti abbonati, effettua l'accesso o abbonati per accedere a tutti i contenuti del sito.
Miriam Zanoletti
Nata nel 1999, ha studiato all’Università Ca’ Foscari di Venezia e Albert-Ludwig di Friburgo, conseguendo la laurea magistrale in Lingue e Letterature tedesca e russa.
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI