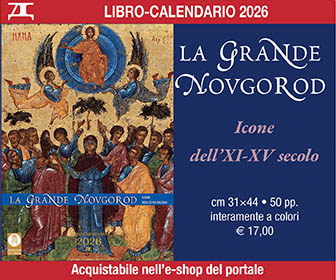20 Agosto 2025
«Mi sento colpevole per il mio paese»
Una giornalista impavida che non si limita a raccontare ma che si implica direttamente in ciò che vede. Aiutare gli sfollati, testimoniare i drammi delle popolazioni fanno parte del suo lavoro. Per placare il senso di colpa in quella cosa più grande che è la solidarietà. Nostra intervista esclusiva.
Questa intervista alla fotografa russa che ha preferito vivere in Ucraina piuttosto che a casa sua, esprime un dolore che non trova pace. Illumina lo strazio interiore di una persona che si sente tradita nella sua appartenenza più profonda, e nega ogni fiducia ai suoi compatrioti russi. Ma c’è qualcosa che, nonostante tutto il suo estremo pessimismo, ne contraddice radicalmente la disperazione e apre spiragli di speranza: vivendo all’insegna di un senso di colpa assoluto aiuta gli altri, e noi stessi, a vincerlo, proprio con la testimonianza del proprio dolore e con la testimonianza che offre quando parla dei tanti suoi compatrioti che «stringendo i denti» aiutano di nascosto gli ucraini. Nostra intervista esclusiva.
Viktorija, ci dica in breve di sé.
Mi chiamo Viktorija Ivleva e sono una giornalista, fotografa e volontaria russa. In Russia sono stata catalogata come «agente straniero». L’Ucraina è entrata nella mia vita solo con il Majdan, fino a quel momento questo paese per me era semplicemente un cagnolino che scodinzolava accanto alla Russia. Non mi interessava affatto.
(foto d’apertura: © V. Ivleva)
La lettura dell'articolo completo è riservata agli utenti abbonati, effettua l'accesso o abbonati per accedere a tutti i contenuti del sito.
Viktorija Ivleva
Nata nel 1956 a Leningrado, è fotografa e giornalista. Nella sua lunga esperienza è stata nelle aree più critiche del pianeta, dall’Africa al Caucaso, partecipando a diverse missioni umanitarie internazionali. Ha lavorato per numerose testate russe e internazionali. Attualmente vive in Ucraina e dal dicembre 2024 è stata inserita nell’elenco degli «agenti stranieri» del Ministero della giustizia russo.
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI