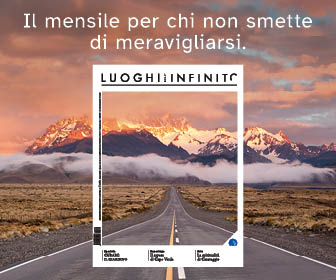30 Luglio 2025
Lo spirito di Helsinki non è morto
Cinquant’anni fa 35 paesi firmarono degli accordi che siglavano il calo della tensione internazionale guardando alla collaborazione. Furono anche un appiglio per i dissidenti all’Est. Cosa resta oggi del loro spirito?
«Il nostro treno è in fiamme e non abbiamo più pulsanti da premere».
Con queste rime, scritte nel 1988 ma ancora taglienti e dolorosamente attuali, gli Akvarium – una delle band dissidenti più famose della Russia sovietica, oggi purtroppo immersa nel silenzio più assoluto della repressione di Putin – descrivevano il senso di disperazione di una generazione che vedeva nel collasso dell’impero sovietico la fine di un mondo a loro familiare, di cui oggi, tolto il sedicente velo ideologico comunista, non rimane altro se non una fredda autocrazia, che vede nell’uso della forza l’unico vero strumento di politica estera ed interna.
Akvarium, Il treno in fiamme (B. Grebenščikov, 1988).
(Immagine d’apertura: l’apertura della CSCE a Helsinki, 1975 – wikipedia)
La lettura dell'articolo completo è riservata agli utenti abbonati, effettua l'accesso o abbonati per accedere a tutti i contenuti del sito.
Mario Mauro
Laureato in filosofia all’Università Cattolica di Milano. È stato vicepresidente del Parlamento europeo, ministro della difesa italiano, rappresentante della presidenza OSCE per la libertà religiosa. È esperto di politiche educative e geopolitica e autore di diverse pubblicazioni. È stato Incaricato speciale dell’OSCE per la libertà religiosa dal 2007 al 2010. Attualmente è presidente del Centro studi Meseuro per l’Europa del Mediterraneo.
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI