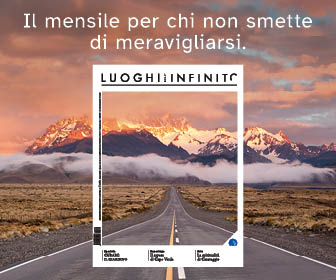27 Ottobre 2025
In cammino dal «sé» al «noi»
Il convegno di Russia Cristiana del 2021, di cui sono appena usciti gli atti, ha toccato alcune tematiche che oggi si rivelano ancora più attuali di allora. A partire da esperienze molto varie, i relatori ne hanno messo al centro la radice profonda, ossia l’autentica affermazione dell’io, possibile solo nell’accoglienza delle reciproche diversità. L’alternativa è una catena infinita di conflitti.
Sono usciti da poco, con il titolo Riflessioni alla vigilia della guerra. Persona, società, Stato. Dall’Est all’Ovest, in ascolto di esperienze inattese che ri-dicono l’io, gli atti del Convegno tenutosi a Milano il 5 e 6 novembre 2021 e promosso da Russia Cristiana e dal Centro Culturale di Milano. Non si era ancora conclusa la pandemia da Covid-19, e un po’ per questo, ma soprattutto per agevolare i relatori più lontani, l’evento si era svolto in gran parte in collegamento.
I lavori si sono articolati in tre sessioni: il recupero della memoria che libera dall’autoreferenzialità nell’affrontare il presente; il dialogo con l’altro come possibilità di crescita; una nuova comprensione della libertà come realizzazione di sé nel «noi». Tre grandi passi di uno stesso cammino verso un modo nuovo di concepire i rapporti umani, illustrati da esperienze molto eterogenee per storia e provenienza, con interventi da Italia, Russia, Algeria, Polonia, Paesi Bassi e Repubblica ceca. I contributi spaziano dall’arte alla memoria, dalla filosofia all’impegno civile, al cristianesimo vissuto.
Nelle loro riflessioni, i relatori avevano individuato fin da allora le radici dei conflitti che covavano sotto la cenere e sarebbero esplosi di lì a poco, e che oggi mostrano i loro frutti avvelenati: la solitudine, il conseguente rifugiarsi in gruppi omogenei e chiusi che danno l’illusione della sicurezza e sui quali è comodo scaricare il peso della libertà personale; la demonizzazione dell’altro, il quale da occasione di crescita diventa ostacolo da abbattere; la preferenza data al controllo e all’uso della forza piuttosto che al dialogo e al rispetto di leggi e accordi su cui si è basata a lungo la convivenza fra individui e popoli.
Tuttavia, i relatori non si sono fermati qui, ma hanno soprattutto messo in luce dei modi imprevisti di guardare e affrontare la realtà che permettono di vivere dentro a situazioni disumane senza esserne sopraffatti, anzi, «umanizzandole» dall’interno.
Nel «tempo sospeso» imposto negli anni ‘70 dal regime comunista cecoslovacco, con l’atomizzazione della società e la distruzione di tutti i legami che potevano vincere la solitudine, non c’era posto per il mistero, l’imprevisto e quindi per la storia come avvenimento. Tuttavia, la polis parallela immaginata dal pensatore e matematico Václav Benda e messa a tema nell’intervento di A. Bonaguro, ha guadagnato spazi di libertà sempre maggiori non a partire da «una visione aprioristica, teorica, del cambiamento del sistema, ma dalle intenzioni della vita e dai bisogni autentici di uomini concreti», come afferma Havel. Fra questi bisogni, l’aiuto fattivo ai prigionieri di coscienza. Gli incontri che si svolgevano a casa dei Benda in un’atmosfera familiare, tra cene e bucati, hanno contribuito, pur fra tante difficoltà, a una transizione pacifica dal regime totalitario alla democrazia.
Così, con semplicità e pazienza si sono create le condizioni perché oggi, ad esempio, nei pressi di Praga, su un terreno che prima aveva visto contrapposti cattolici e hussiti, poi aveva ospitato un campo delle SS e infine era stato teatro delle persecuzioni comuniste, sia potuto sorgere un monastero di clausura fondato dalle Trappiste di Vitorchiano.
La badessa madre Lucia nel suo contributo ha raccontato che fondare in un nuovo paese significa diventare una cosa sola con la Chiesa, i vivi e i defunti di quella terra, abbracciando le sue diversità e tutti gli incontri imprevisti che il Signore offre. Persone totalmente ignare del cristianesimo si sono avvicinate per curiosità attratte dalla bellezza della liturgia, gli ordini religiosi locali sono stati incondizionatamente solidali con loro, sono arrivate offerte di aiuto dai vicini, sono state accolte giovani segnate da una cultura profondamente individualista, che nell’incontro con le monache hanno cominciato a gustare una comunione che è appartenenza al Corpo di Cristo, che poi si declina in piccoli gesti quotidiani, come mangiare sedute a tavola con piatti e posate o visitare i propri cari defunti al cimitero, semplici atti di amore che diamo per scontati, ma che vengono meno se si perde la memoria della loro origine.

(youtube)
Sulla memoria è incentrato, pur da un’angolatura diversa, anche l’intervento di Nikolaj Epple, giornalista e filologo che, citando alcuni studi ed esperienze, si interroga su come superare l’«impunità sistemica» che in alcuni paesi del mondo impedisce un passaggio pacifico da un regime dittatoriale o comunque fondato su crimini e patenti ingiustizie, a una democrazia solida e duratura che garantisca la convivenza fra offensori e offesi e i rispettivi discendenti. Oggi il problema è ancora più attuale di ieri, visti i conflitti e le violazioni dei diritti umani in corso, che minano la pace e lo stesso futuro del mondo.
Per superare la dicotomia fra vendetta e oblio delle ingiustizie passate, che, se non risolte possono solo inasprire l’odio, nella storia del ‘900 si è cercato di individuare alcune soluzioni. Applicare la giustizia punitiva sul modello del Processo di Norimberga, in alcuni casi, come quello dei paesi dell’Est, secondo il relatore è difficile, sia perché è impossibile arrestare tutti i colpevoli, sia perché il tempo per farlo è scaduto.
La maggior parte dei paesi che cercano di sciogliere i nodi di un «passato criminale» ricorrono alla «giustizia riparativa», la cui logica secondo Epple è il principio del perdono. Il relatore cita poi la Truth and Reconciliation Commission, il più celebre istituto di giustizia di transizione che ha contribuito a superare quasi senza traumi l’Apartheid in Sudafrica, dove la verità è condizione della riconciliazione e «i tribunali sono importanti non in sé ma come condizione per cui una società divisa dai crimini possa continuare a esistere in futuro come un corpo unitario».
Anche qui il perdono ha un ruolo chiave. Infatti, è proprio il perdono che permette di ricordare quanto è successo perché il passato criminale non si ripeta e al tempo stesso di lavorare per sanare le divisioni e continuare a vivere insieme nel futuro. Prendendo spunto dallo studioso americano Griswold, il relatore spiega che il perdono è rinunciare al risentimento verso l’offensore, senza però dimenticare il danno subìto e senza sollevarlo dalla responsabilità per il male compiuto. Solo a partire da queste due categorie è possibile un lavoro pubblico sul passato.
Oggi però purtroppo il perdono assume nell’opinione pubblica una connotazione negativa, perché erroneamente associato all’oblio e alla deresponsabilizzazione dei criminali. Per restituire al perdono la sua accezione positiva, secondo Epple è necessario un programma educativo articolato in due punti: da un lato bisogna spiegare che, per essere perdonato, l’offensore deve riconoscere la sua colpa e chiedere perdono; dall’altro bisogna diffondere ampiamente il racconto di casi reali di perdono, ponendo l’accento non sulle vittime che hanno perdonato ma sui criminali che hanno saputo chiedere perdono e compiere un lavoro di espiazione.
Se il tema della memoria e dell’elaborazione dei traumi va oggi per la maggiore, non si può dare per scontato che si tratta di un lavoro difficile, la cui fatica e complessità vanno messe in conto. Inoltre, pur avendo una valenza sociale, la dinamica del perdono va sempre verificata nella dimensione personale, «per non correre il rischio di politicizzazioni o ideologizzazioni». Secondo Epple, «la prassi cristiana di regolare le proprie azioni usando criteri personali può costituire qui un aiuto importante».
Oggi, a quattro anni di distanza, in un periodo di crescenti polarizzazioni e di demonizzazione reciproca, i contributi di questo convegno suggeriscono dei punti di partenza per ricostruire rapporti che, proprio grazie alla fatica e al lavoro che comportano, non fanno leva su istinti immediati e a buon mercato, ma poggiano su basi più solide e durature.
Sulla necessità di questo lavoro si è espresso papa Leone XIV durante la Veglia di Pentecoste del 7 giugno di quest’anno: «Tutta la creazione esiste solo nella modalità dell’essere insieme, talvolta pericoloso, ma pur sempre un essere insieme (…). E ciò che noi chiamiamo storia prende forma solo nella modalità del riunirsi, del vivere insieme, spesso pieno di dissidi, ma pur sempre un vivere insieme. Il contrario è mortale, ma purtroppo è sotto i nostri occhi, ogni giorno».
Riflessioni alla vigilia della guerra
Interventi di: N. Epplè, A. Dell’Asta, A. Bonaguro, I. Ščerbakova, M. Borghesi, F. Braschi, M. Pagani, Z. Nosowski, J.F. Thiry, T. Larsen, I. Levontina, A. Soldatov, M. Lucia, s. Alžběta.
pp. 136, € 15 → Acquistalo nell’e-shop
(foto d’apertura: M. Budanova-Pristavskaya, unsplash.com)
Delfina Boero
È ricercatrice presso la Fondazione Russia Cristiana. Fra i suoi interessi, la storia e la cultura della Repubblica Democratica Tedesca, la vita religiosa e culturale in URSS, nella Federazione Russa e nelle ex Repubbliche sovietiche.
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI