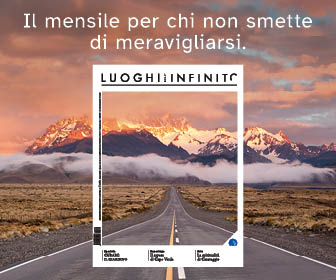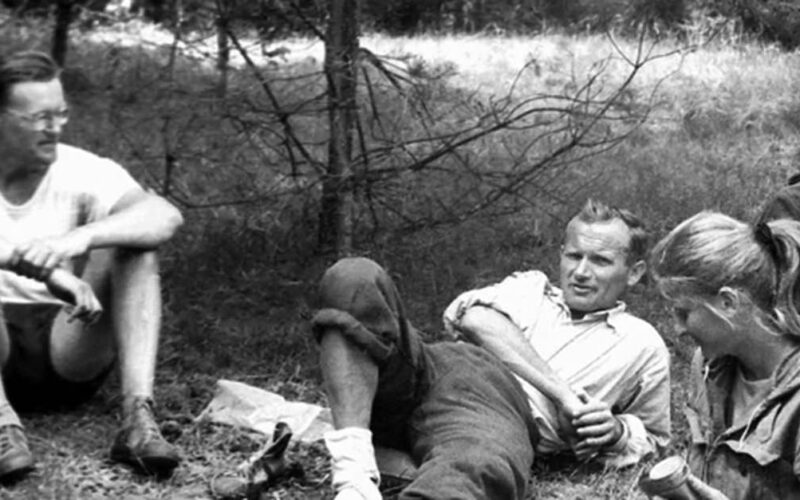- HOME /
- ARTICOLI /
- 2025 /
- Editoriale /
- Leone XIV e le Chiese orientali «preziose e provate»
29 Ottobre 2025
Leone XIV e le Chiese orientali «preziose e provate»
Un papa di estrazione decisamente occidentale ci richiama a riconoscere, conoscere ed amare le Chiese orientali. Questo richiamo inaspettato ci riguarda da vicino.
A meno di un mese dall’inizio del suo “nuovo lavoro” il papa1, celebrando l’anniversario del Concilio di Nicea, ha ricordato che l’unità, come ogni cosa buona che ci attendiamo dalla vita, anzi, come la cosa buona della vita non è «il frutto dei nostri sforzi, né sarà realizzata attraverso modelli o schemi prestabiliti» (Nicea) ma è un dono che va invocato dallo Spirito Santo.
Subito dopo, precisando che è «tratta dalla tradizione orientale», ha recitato la preghiera del Re Celeste, la preghiera sotto la cui protezione è posto ogni lavoro, come pure l’inizio della Divina Liturgia, perché questa tradizione, come Nicea, «non è solo un evento del passato, ma una bussola che deve continuare a guidarci verso la piena unità visibile dei cristiani» (Nicea).
Con questa bussola siamo invitati a muoverci, nel solco di una tradizione il cui senso dobbiamo ogni volta riprendere.
Quello che il papa ci dice non è una riflessione astratta o per specialisti, rivolta solo ad appassionati della Russia, ma uno strumento per stare davanti a tutto il reale con il desiderio di conoscerne il senso, per vivere nel dramma o nella tragedia di tutti i giorni, perché il papa descrive la situazione in cui viviamo quando parla delle Chiese orientali e dice che le loro terre sono «mai come ora sconvolte dalle guerre, prosciugate dagli interessi, avvolte da una cappa di odio che rende l’aria irrespirabile e tossica» (ROACO); non parla solo agli specialisti o a chi ha una esperienza particolare ma parla a tutti e a ciascuno di noi: l’odio che rende l’aria irrespirabile e tossica, gli interessi che ci rendono insensibili alle sofferenze altrui e alla semplice esistenza degli altri sono il quadro di fondo della nostra vita.
Parlare delle Chiese orientali a questo ci deve aiutare: a renderci conto di quanta aria ci manca, a cercare un’aria respirabile e a tornare a respirare a pieni polmoni; se volete, a convertirci.
Le Chiese orientali, «preziose e provate», vanno conosciute
Il primo passo che il papa ci mette davanti, per tornare a respirare a pieni polmoni, o con due polmoni, è quello, per noi occidentali, della conoscenza delle Chiese orientali, «così preziose e provate» (ROACO): le Chiese orientali vanno conosciute perché sia chiaro il significato di questi due aggettivi – «preziose» e «provate» – che non sono, nel loro peso, un semplice timbro retorico, ma si riferiscono a una storia precisa e alla situazione attuale.
La storia
La storia delle Chiese orientali è una storia gloriosa segnata da «aspre sofferenze» (GCO), sofferenze che sono venute dal mondo, ma sofferenze che sono venute anche dai fratelli. Sono infatti le persecuzioni (prima fra tutte la persecuzione della Chiesa greco-cattolica soppressa dallo pseudo-concilio di L’viv del 1946, quando quella Chiesa, con la collaborazione della Chiesa ortodossa, fu messa fuori legge), una storia che non bisogna dimenticare non tanto per sottolineare l’infamia dei persecutori (che pure bisogna conoscere), ma la grandezza della fedeltà e della fede dei perseguitati, dei tanti greco-cattolici che diedero la vita (testimoni come Romža, Szeptycki, il beato Pietro Paolo Oros).
Ma accanto alle persecuzioni del regime c’è stata anche la lunga storia della nostra disattenzione e presunzione: «Oltre un secolo fa, Leone XIII notò che “la conservazione dei riti orientali è più importante di quanto si creda” e a questo fine prescrisse persino che “qualsiasi missionario latino, del clero secolare o regolare, che con consigli o aiuti attiri qualche orientale al rito latino” fosse “destituito ed escluso dal suo ufficio”» (GCO).

Sergiev Posad (Olga Petrova/Pexels).
La situazione attuale
La situazione attuale è caratterizzata da un attacco condotto «con una veemenza diabolica mai vista prima» (ROACO). È qualcosa che, dice il papa, va documentato e specificato in tutte le sue caratteristiche; e parlando di queste caratteristiche entra in una descrizione tanto precisa e minuziosa che diventa anche l’affidamento di un compito di ricerca e conoscenza: «Siamo chiamati noi tutti, umanità, a valutare le cause di questi conflitti, a verificare quelle vere e a cercare di superarle, e a rigettare quelle spurie, frutto di simulazioni emotive e di retorica, smascherandole con decisione. La gente non può morire a causa di fake news» (ROACO).
È il lavoro informativo, di igiene mentale e cognitiva cui strumenti come «La Nuova Europa» cercano di far fronte.
Da questa conoscenza deve nascere un giudizio, perché la nostra solidarietà e la nostra compassione di fronte a tante sofferenze passate e di fronte alla tragedia presente, di fronte alla «veemenza diabolica» dell’attacco di oggi non siano il frutto di un sentimento che passa o, peggio, dell’odio che ci può avvelenare fino a rendere «l’aria irrespirabile e tossica» (ROACO).
Tale giudizio deve avere un criterio che va posto non alla fine, ma all’inizio di ogni lavoro e deve essere determinato sin dall’origine e in ogni suo passo da criteri di fede, se vuole evitare di diventare prima o poi uno dei tanti giudizi correnti. È solo a questa condizione che da questo giudizio discenderanno poi una condivisione autentica, per un cambiamento e un’azione non riducibili a semplici reazioni (politiche o sentimentali che siano).
Il giudizio e la condivisione
In base a una informazione precisa e documentata, il papa ci richiama a un giudizio preciso e molto circostanziato perché richiama i singoli punti in cui l’umanità di oggi vien meno a se stessa (facendo prevalere la legge del più forte e la legge dell’interesse particolare, nel totale rifiuto del diritto delle genti): «È veramente triste assistere oggi in tanti contesti all’imporsi della legge del più forte, in base alla quale si legittimano i propri interessi. È desolante vedere che la forza del diritto internazionale e del diritto umanitario non sembra più obbligare, sostituita dal presunto diritto di obbligare gli altri con la forza. Questo è indegno dell’uomo, è vergognoso per l’umanità e per i responsabili delle nazioni» (ROACO).
Il giudizio cristiano non si ferma alla denuncia immediata del male, ma cerca di coglierne le radici e le ragioni malate, con un’operazione che è nello stesso tempo l’indicazione di vie e ragioni diverse dalla forza e dall’interesse; si tratta allora, dice il papa, rinviandoci esattamente al cuore della fede e quindi all’origine di ogni giudizio autenticamente cristiano, di «imitare Cristo, che ha vinto il male amando dalla croce, mostrando un modo di regnare diverso da quello di Erode e Pilato: uno, per paura di essere spodestato, aveva ammazzato i bambini, che oggi non cessano di essere dilaniati con le bombe; l’altro si è lavato le mani, come rischiamo di fare quotidianamente fino alle soglie dell’irreparabile» (ROACO).
La condivisione autentica è quella che viene da una immedesimazione all’amore crocifisso e da questa immedesimazione può respingere la logica della forza, dei nuovi Erode che uccidono per non avere rivali nel dominio del mondo, come pure la logica dell’interesse, dei nuovi Pilato che preferiscono chiudere gli occhi davanti al male, stare in pace invece che cercare la pace, con tutto il rischio che implica questa ricerca e con la coscienza che questa ricerca ci porta in un mondo e verso una forza che non possediamo.

Rostov (Oleg Podlesnykh/Pexels).
Il giudizio e la condivisione ci mettono sulla strada del cambiamento che nasce dalla testimonianza delle Chiese orientali: una testimonianza antica che consiste nella riscoperta dell’uomo nella sua integralità di essere creato a immagine e somiglianza di Dio, per una grazia imprevedibile che trasporta la nostra miseria terrena nel piano celeste e ci fa partecipare al percorso di divinizzazione.
Questo è, recuperato nelle parole di Leone, quanto ci è stato sempre insegnato sulla tradizione orientale che ritroviamo oggi nella sua attualità e nel suo valore personale e universale: come ci diceva don Giussani: «Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice»2.
Nelle parole di papa Leone abbiamo l’umano integrale che vive un altro mondo in questo mondo e trova una via diversa dalla violenza e dall’interesse.
Nella testimonianza delle Chiese orientali abbiamo «il senso drammatico della miseria umana [che] si fonde con lo stupore per la misericordia divina, così che le nostre bassezze non provochino disperazione, ma invitino ad accogliere la grazia di essere creature risanate, divinizzate ed elevate alle altezze celesti» (GCO).
Troviamo l’altro mondo in questo mondo:
«la grazia e la bellezza delle tradizioni orientali, di liturgie che lasciano abitare a Dio il tempo e lo spazio, di canti secolari intrisi di lode, gloria e mistero, che innalzano un’incessante richiesta di perdono per l’umanità» (ROACO).
E in questo percorso troviamo la via per una salvezza imprevedibile: «Quanto bisogno abbiamo di recuperare il senso del mistero, così vivo nelle vostre liturgie, che coinvolgono la persona umana nella sua totalità, cantano la bellezza della salvezza e suscitano lo stupore per la grandezza divina che abbraccia la piccolezza umana! E quanto è importante riscoprire, anche nell’Occidente cristiano, il senso del primato di Dio, il valore della mistagogia, dell’intercessione incessante, della penitenza, del digiuno, del pianto per i peccati propri e dell’intera umanità (penthos), così tipici delle spiritualità orientali! Perciò è fondamentale custodire le vostre tradizioni senza annacquarle, magari per praticità e comodità, così che non vengano corrotte da uno spirito consumistico e utilitarista» (GCO).
Si tratta poi di una testimonianza recente che va compresa nella sua potenza, non meno grande di quella antica, perché nelle sofferenze attuali, dall’«abisso della violenza» che sconvolge le Chiese orientali, queste ci mostrano una via per la pace, ben diversa dal mondano stare in pace; è una via che non passa dal silenzio sulla tragedia, anzi nasce da una domanda che può essere angosciosa: «La fede del vostro Popolo ora è messa a dura prova. Molti di voi, da quando è iniziata la guerra, sicuramente si sono chiesti: Signore, perché tutto questo? Dove sei? Che cosa dobbiamo fare per salvare le nostre famiglie, le nostre case e la nostra Patria? Credere non significa avere già tutte le risposte, ma confidare che Dio è con noi e ci dona la sua grazia, che Egli pronuncerà l’ultima parola e la vita vincerà contro la morte» (GGCU).
Sulla tragedia e sull’odio, ci dice dunque il papa, prevale «la certezza della Pasqua in ogni travaglio della vita» (GCO); la storia delle Chiese orientali e le testimonianze recenti ci dicono che «il più grande peccato è non credere nelle energie della Risurrezione» (GCO) così che «su tutto questo orrore, sui massacri di tante giovani vite, che dovrebbero provocare sdegno, perché, in nome della conquista militare, a morire sono le persone, si staglia un appello: non tanto quello del papa, ma di Cristo, che ripete: “Pace a voi!” (Gv 20,19.21.26). E specifica: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi” (Gv 14,27)» (GCO).
Con una precisazione ulteriore perché sia chiaro che questa pace non è lo stare in pace del mondo:
«La pace di Cristo non è il silenzio tombale dopo il conflitto, non è il risultato della sopraffazione, ma è un dono che guarda alle persone e ne riattiva la vita. Preghiamo per questa pace, che è riconciliazione, perdono, coraggio di voltare pagina e ricominciare» (GCO).
Noi potremmo ricordare tante di queste storie di una vita che continua, le abbiamo viste l’anno scorso con la mostra sugli Hospice, le abbiamo riviste in forma diversa quest’estate al Meeting con la mostra sull’Ucraina.

Suzdal’ (Diana/Pexels).
Dalla storia e dalla vita nasce un’azione articolata
Conoscere per amare in vista del bene comune. La prima cosa che ci viene indicata come pista di lavoro dal papa è lo studio, innanzitutto della tradizione e delle sue caratteristiche: «Vorrei che questa luce di sapienza e di salvezza sia più conosciuta nella Chiesa cattolica, nella quale sussiste ancora molta ignoranza al riguardo e dove, in alcuni luoghi, la fede rischia di diventare asfittica anche perché non si è realizzato il felice auspicio espresso più volte da san Giovanni Paolo II, che 40 anni fa disse: “La Chiesa deve imparare di nuovo a respirare con i suoi due polmoni, quello orientale e quello occidentale” (Discorso al Sacro Collegio dei Cardinali, 28 giugno 1985). Tuttavia, l’Oriente cristiano si può custodire solo se si ama; e si ama solo se si conosce. Occorre, in questo senso, attuare i chiari inviti del Magistero a conoscerne i tesori, ad esempio cominciando a organizzare corsi di base sulle Chiese orientali nei seminari, nelle facoltà teologiche e nei centri universitari cattolici (cfr. s. Giovanni Paolo II, Lett. ap. Orientale lumen, 24; Congregazione per l’Educazione Cattolica, Lett. circ. En égard au développement, 9-14)» (ROACO).
Ma questo – lo studio e la conoscenza – è solo il primo passo di un percorso che per noi è sempre stato chiaro, ma che ora l’indicazione così autorevole e la situazione così urgente ci deve far riprendere con rinnovata coscienza e serietà: non è un optional.
E però è solo il primo passo: la situazione in cui viviamo è cambiata: quelli che un tempo erano amici lontani che incontravamo occasionalmente e singolarmente ora ci stanno accanto come comunità e ci chiamano a una condivisione concreta e quotidiana di esperienze e di vita
Si parla proprio di condivisione di vita: «E c’è bisogno pure di incontro e di condivisione dell’azione pastorale, perché i cattolici orientali oggi non sono più cugini lontani che celebrano riti ignoti, ma fratelli e sorelle che, a motivo delle migrazioni forzate, ci vivono accanto. Il loro senso del sacro, la loro fede cristallina, resa granitica dalle prove, e la loro spiritualità che profuma del mistero divino possono giovare alla sete di Dio latente ma presente in Occidente» (ROACO).
Ed è una storia che sta prendendo sempre più carne nell’incontro con le comunità orientali che vivono accanto a noi. Sarà una storia da scrivere insieme.
(Immagine d’apertura: Elina Allaia/Pexels).
Adriano Dell’Asta
Già docente di lingua e letteratura russa presso l’Università Cattolica. Accademico della Classe di Slavistica della Biblioteca Ambrosiana, è vicepresidente della Fondazione Russia Cristiana.
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI