
- HOME /
- ARTICOLI /
- 2025 /
- Recensioni /
- Il viaggio della vita
24 Marzo 2025
Il viaggio della vita
Nell’anno del Giubileo della Speranza, il racconto di un pellegrinaggio nella Russia prerivoluzionaria ci aiuta a riprendere con nuovo slancio il cammino, dopo il dramma del COVID e nell’attuale situazione di «terza guerra mondiale a pezzi».
Per la prima volta è accessibile al lettore italiano nella bella traduzione di Sergio Rapetti la povest’ («novella», «lungo racconto») autobiografica Pellegrinaggio dello scrittore russo Ivan Šmelëv. Il titolo suona particolarmente attuale nell’anno giubilare 2025 il cui motto, scelto da papa Francesco, è «Pellegrini di speranza».
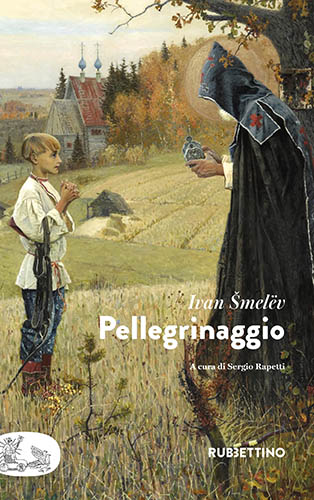
I. Šmelëv, Pellegrinaggio, a cura di S. Rapetti, Rubbettino 2024.
Qualche anno fa Francesco sottolineava il valore del giubileo e quello ad esso legato del pellegrinaggio ai luoghi santi, come momento di rinascita dopo il COVID, quando si era toccato con mano «il dramma della morte in solitudine, l’incertezza e la provvisorietà dell’esistenza». Papa Francesco sottolineava che tutti avevano sperimentato la limitazione di alcune libertà, e che la pandemia, «oltre al dolore, ha suscitato talvolta nel nostro animo il dubbio, la paura, lo smarrimento».
Il pontefice vedeva nel Giubileo l’occasione per «tenere accesa», dopo questo momento tragico, «la fiaccola della speranza che ci è stata donata, e fare di tutto perché ognuno riacquisti la forza e la certezza di guardare al futuro con animo aperto, cuore fiducioso e mente lungimirante». «Tutto ciò però sarà possibile – proseguiva il pontefice, – se saremo capaci di recuperare il senso di fraternità universale…»: il pellegrinaggio ci fa comprendere la nostra provvisorietà sulla terra, che non possediamo ma che il Signore ci ha affidato. Da qui, uno sguardo libero e grato sulla realtà, per non trascurare, «lungo il cammino, di contemplare la bellezza del creato e di prenderci cura della nostra casa comune». Ma ciò è possibile solo recuperando «il desiderio di stare alla presenza del Signore, ascoltarlo e adorarlo» con la preghiera.
In circostanze apparentemente lontane, tutti questi elementi si ritrovano proprio nella povest’ del russo Šmelëv (1873-1950), la cui opera in Italia non è ancora conosciuta come meriterebbe.
Lo scrittore aveva lavorato a fianco di Gor’kij, che lodava «la sana inquietudine» e le «parole semplici e belle» dei suoi racconti, e di Bunin, futuro Nobel per la letteratura. Molti anni dopo, nel 1932, Thomas Mann avrebbe proposto la candidatura di Šmelëv al comitato per il Nobel.
Mettendo mano a questo racconto, anche Šmelëv si riscopre pellegrino, e la scrittura diventa per lui una risalita dagli inferi in cui era precipitato poco dopo la rivoluzione bolscevica. Profondamente religioso, inizialmente di idee progressiste e liberali, lo scrittore aveva salutato con favore la rivoluzione del 1905 e quella del febbraio 1917, ma le violenze e l’omologazione forzata seguite all’ottobre avevano cancellato le speranze in un futuro migliore per il suo paese.
Nel 1918, durante la guerra civile, si era trasferito con la moglie nella Crimea occupata dai bianchi per stare vicino al figlio, ufficiale dell’esercito zarista tornato dal fronte gravemente malato. Questi, rimasto in patria nella speranza di un’amnistia, non era espatriato con l’esercito di Vrangel’. Era stato quindi arrestato dai bolscevichi ed era sparito nel nulla. La notizia certa della fucilazione del figlio avrebbe raggiunto lo scrittore due anni dopo, nell’emigrazione.
Da una casetta in collina di fronte al mare, Šmelëv aveva assistito alle crudeli rappresaglie dei vincitori e alla carestia non soccorsa dal governo sovietico, rischiando egli stesso, con la moglie, di morire per fame. Da qui, la sofferta decisione di emigrare, prima in Germania e poi in Francia dove, ospite di Bunin, aveva scritto l’epopea Il sole dei morti, che rievoca magistralmente questi tre anni di inferno.
Nonostante l’affettuosa accoglienza di amici e parenti già stabilitisi in Francia, Šmelëv nei primi tempi aveva vissuto l’emigrazione come una lacerante sconfitta, come l’impossibilità definitiva di contribuire alla crescita del proprio paese, come disperazione per la violenza con cui era stato privato per sempre del figlio e della propria stessa vita.
Da questo baratro era risalito faticosamente aggrappandosi alla fede e alla sua vocazione letteraria, di cui fa parte anche Pellegrinaggio, scritto fra il 1930 e il 1931. Sono i ricordi semplici di Ivan bambino, che a sei anni partecipa al suo primo pellegrinaggio a piedi di alcuni giorni da Mosca al Monastero della Trinità e di san Sergio, grande luogo di devozione dell’ortodossia russa.
Il monastero ospita la tomba di uno dei santi più amati dal popolo per la fede nella Trinità con cui nel Medioevo aveva trasfigurato il volto della propria patria devastata dalle invasioni tataro-mongole. Il piccolo Ivan, accompagnato da una bambina sua coetanea e guidato da alcuni adulti, persone di fiducia del padre sempre in viaggio d’affari, scopre che il pellegrinaggio è il viaggio della vita, la verifica se il cristianesimo imparato in famiglia mantiene la promessa di rendere la vita più bella, affettuosa e avventurosa.
La meta del monastero, paradigma in terra del senso ultimo dell’esistenza, amplifica in effetti all’infinito il fascino della campagna russa, colorata e rigogliosa nelle lunghe giornate di inizio estate, con i suoi fiumi e laghi, le chiesette e le croci nel folto dei boschi, la varietà di fiori, frutti e animali e i profumi dei cibi ricevuti in dono o acquistati per strada, le atmosfere indimenticabili di un tramonto o della frescura dopo un temporale.
Il fine ultimo alimenta la fratellanza cristiana e unisce persone dei più disparati ceti sociali, livelli culturali e temperamenti: l’«addetta ai bagni» Domna Parfenovna, pettegola e invadente, cammina a fianco del saggio ed equilibrato ma non impeccabile carpentiere Gorkin, i bambini innocenti, ma anche testardi e capricciosi, assorbono come spugne e rielaborano le spiegazioni degli adulti.
Più ci si avvicina alla meta, più i conflitti si appianano, fermi restando i limiti personali e le asperità del carattere: «Nel cammino della vita, in chi è alla ricerca di un suo possibile senso, dovrebbe affermarsi, come minimo, l’esigenza di un pacificante criterio: se non l’amore, intanto almeno la semplice, riguardosa attenzione all’altro», conclude Rapetti nella sua introduzione all’opera.
Le contraddizioni restano, ma non arrestano il cammino. La debolezza umana non è censurata ma fa parte del viaggio ed è anzi descritta con un’ironia benevola che non è mai sarcasmo, perché è superata nel perdono. Alla fine del percorso, delusioni e i rimpianti si aprono su nuovi orizzonti. Il giovane e sanguigno Fedja, che aspirava ad entrare in monastero, non riceverà dallo starec Varnava la benedizione a intraprendere il noviziato ma quella, non meno affascinante, di santificare il mondo dal suo interno con il suo lavoro di panettiere e forse di futuro sposo e padre.
Il dolore di Gorkin, che si ritiene responsabile, pur involontario, della morte dell’apprendista Griša caduto da un’impalcatura, si scioglie nel perdono amministrato con un sorriso radioso e con affetto dallo stesso padre Varnava.

K. Gorbatov, La Lavra della Trinità e di san Sergio, 1915. (wikipedia)
Dai ricordi di Šmelëv emerge spesso una Russia prerivoluzionaria idealizzata e a tratti fiabesca, permeata da una religiosità cordiale, dove ogni incontro, compresi gli imprevisti più spiacevoli, è guidato dalla Provvidenza, che tutto ricompone in un ordine così bello che il puro intelletto umano non sarebbe in grado di architettare. Questa, che per il cristiano è una verità di fede sicura ma difficile da accogliere nel concreto, viene professata e vissuta con una naturalezza che ha dell’inverosimile. Qui gioca senz’altro la nostalgia, comprensibile in un esule, che, all’indomani della Seconda guerra mondiale si era dovuto difendere dall’accusa di collaborazionismo per aver pubblicato una serie di articoli sull’unico giornale in lingua russa attivo a Parigi e controllato dagli occupanti nazisti. Šmelëv avrebbe motivato la scelta, affermando candidamente: «Sia pure attraverso un foglio nemico, intendevo “bisbigliare” la verità ai miei lettori».
D’altra parte, lo scrittore offre uno spaccato storico prezioso della classe mercantile russa, che a cavallo fra il XIX e il XX secolo, con i suoi piccoli e grandi imprenditori, era intraprendente, colta, amante del bello e del lavoro svolto a regola d’arte, in particolare nella comunità ortodossa dei vecchi credenti, cui Šmelëv apparteneva.
Lo si constata nello stupore di due vecchi artigiani di fronte all’opera di intaglio di un carretto, da cui traspare un’etica del lavoro positiva e per nulla moralista: «Con soltanto la mano e l’occhio non arrivi a fare lavori del genere, ci vuole la gioia dell’anima…». Quella di Šmelëv era una classe sociale numericamente consistente, che avrebbe potuto fare molto per l’evoluzione pacifica della Russia. Il paese alla vigilia della rivoluzione non era composto solo da una classe nobiliare improduttiva e da un proletariato rurale e urbano votato alla miseria, come certa storiografia ha voluto far credere.
Tuttavia, Šmelëv non si limita a rivisitare il passato in chiave positiva, ma in alcuni punti del suo racconto lascia trapelare i semi di un male che cova sotto la cenere e lascia aperto uno scorcio sulle tragedie che avrebbero colpito la Russia alcuni decenni dopo e che ancora oggi si trascinano dolorosamente. Fra questi, il rischio di una religiosità bigotta e aggressiva contro tutto ciò che è «estraneo», come quando l’aitante Fedja, tra l’approvazione generale, «riduce alla ragione» due bestemmiatori a suon di ceffoni e per poco non li annega nel fiume. O la selva di miserabili che attorniano il monastero della Trinità chiedendo l’elemosina, alcuni dei quali, secondo lo scrittore, sembrano approfittare della propria situazione per ingannare la gente «per bene» e non prendere in mano la propria vita: «Mi vedo circondato, con terrore, da tante palpebre sanguigne arrovesciate, occhi spenti dall’albugine, nasi sprofondati, … moncherini, piaghe … E davanti a noi, ancora lontano, la Porta santa anch’essa circondata da braccia alzate, ciotole agitate…». La scena, degna di un quadro di Bosch, e il caos terrificante che ne promana sembrano anticipare gli orrori che seguiranno la rivoluzione.
«Oggi, dopo un secolo che sembra trascorso invano, con i mortiferi frutti avvelenati, nella “nuova Russia” post-sovietica, di un nazional-revanscismo restauratore», come scrive Rapetti, è tanto più importante l’uscita in italiano dell’edizione di quest’opera da lui curata, che ci offre anche un’introduzione e un ricco apparato di note indispensabili alla giusta comprensione del testo. Questa lettura ci invita a disarmarci, a vagliare tutto senza preconcetti e a trattenere quanto di buono ogni popolo ha da offrirci. È un punto di partenza per riprendere a lavorare e a sperare, nonostante tutto, in un futuro migliore.
(immagine d’apertura: B. Miemietz, wikipedia)
Delfina Boero
È ricercatrice presso la Fondazione Russia Cristiana. Fra i suoi interessi, la storia e la cultura della Repubblica Democratica Tedesca, la vita religiosa e culturale in URSS, nella Federazione Russa e nelle ex Repubbliche sovietiche.
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI














